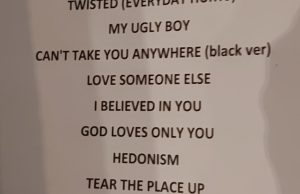CRISTINA DONA’, Nido (Mescal, 1999)
 Cosa fare di fronte a un’opera prima salutata come un piccolo gioiello da tutti quelli che l’hanno ascoltata? Come reagire di fronte alle attese?
Cosa fare di fronte a un’opera prima salutata come un piccolo gioiello da tutti quelli che l’hanno ascoltata? Come reagire di fronte alle attese?
Cristina ha scelto di non stare al centro dell’attenzione e, dopo un tour lunghissimo, decide di rifugiarsi nel suo nido. Un posto dove ripararsi ad osservare indisturbata il mondo che scorre sotto di lei, dove potersi proteggere.
A quasi tre anni di distanza da “Tregua”, “Nido” abbandona le strutture tutto sommato rock dell’esordio, per spostarsi in direzioni solo in apparenza divergenti tra loro: a volte Cristina accentua il lato visionario e sghembo delle sue canzoni, ma si sposta anche, in altre occasioni, verso impreviste movenze pop.
Già la title-track iniziale fa capire che qualcosa è cambiato: arrivano rumori sotterranei e improvvisi, archi che vagano come foglie nel vento. Questa atmosfera spigolosa, quasi lo-fi, viene capovolta subito dopo con una perla assoluta: “Goccia” è un piccolo bolero fatto di immagini vivide, e di una melodia incantata. Come stupirsi che un Grande della Musica come Robert Wyatt se ne sia innamorato a tal punto da volervi prestare la sua voce e la sua cornetta?
Quando l’incanto termina, arriva quello che potrebbe essere l’unico episodio propriamente rock: “Qualcosa che ti lasci il segno” è un’istantanea su un amore che sta per spezzarsi, ma anche l’ennesimo esempio di che testi splendidi sappia scrivere Cristina. Il ritratto di un greve turista sessuale di “Così cara” viene avvolto in un vortice di rumori e riverberi, con un intervento finale di chitarra che ricorda molto quello di “Senza disturbare”, che arrivava a squarciare il canto come una violenta espressione di disgusto. L’aria si distende nuovamente con l’irresistibile melodia de “L’ultima giornata di sole”, per poi incupirsi nuovamente con le inquiete fantasie di “Volo in deltaplano”.
“Brazil”, che ospita ai cori un altro esponente del miglior pop d’autore italiano, Marco Parente, introduce la seconda parte dell’album, che viaggia nuovamente dal pop (“Deliziosa abbondanza”) al rock atipico di “Terapie”, passando per momenti fascinosi e stralunati come “Cibo estremo” e “Mi dispiace”. Le vere perle di questa parte finale sono però altre: “Volevo essere altrove” è straniante come poche, così com’è assolutamente trascinante la sua esplosione ritmica finale; la conclusiva “Mangialuomo” è pura bellezza, con un finale che vira verso il jazz, e gli ottoni ciondolanti quasi ad accompagnare un’ipotetica uscita di scena di una diva.
Emozioni, di questo si tratta. Non sono semplici canzoni, queste. Emozioni. Piccole, come l’osservare dalla finestra, con una tazza di tè in mano, le foglie che cadono dagli alberi, o come una limpidissima giornata d’inverno. Emozioni piccole, ma assolutamente irrinunciabili.