DADAMAH, This Is Not A Dream (Kranky, 1992)
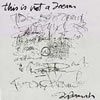 L’ascoltatore ignaro che capitasse, per volontà del fato, a orecchie aperte sulle undici tracce che compongono “This Is Not a Dream” dei Dadamah, potrebbe facilmente incappare nell’errore di considerare questo lavoro capitale della musica contemporanea una perla solitaria. In realtà alle spalle del progetto Dadamah risiede il genio di Roy Montgomery che, oltre a una straordinaria carriera solista, può andare in giro a vantarsi di essere stato il leader tanto dei Dissolve quanto degli Hash Jar Tempo. Insomma, non propriamente quello che si direbbe uno sprovveduto o un principiante.
L’ascoltatore ignaro che capitasse, per volontà del fato, a orecchie aperte sulle undici tracce che compongono “This Is Not a Dream” dei Dadamah, potrebbe facilmente incappare nell’errore di considerare questo lavoro capitale della musica contemporanea una perla solitaria. In realtà alle spalle del progetto Dadamah risiede il genio di Roy Montgomery che, oltre a una straordinaria carriera solista, può andare in giro a vantarsi di essere stato il leader tanto dei Dissolve quanto degli Hash Jar Tempo. Insomma, non propriamente quello che si direbbe uno sprovveduto o un principiante.
Ma torniamo a occuparci di “This Is Not a Dream”, album semplicemente perfetto, in grado di condensare in poco più di un’ora il senso stesso del rock degli anni ’90, navigando a vele spiegate in quella zona di nessuno che lambisce il post-rock – che dopotutto è ancora un arzillo bambinetto quando vede la luce questo lavoro -, sfiora l’irruenza indie e non si dimentica del passato più o meno recente. Per comprendere meglio il senso di quanto sto affermando basterà lasciarsi rapire da “Limbo Swing” che parte sussurrando accenni di chitarra, vi accompagna un cantato femminile che ricorda l’indolenza aulica di Dean Wareham dei Galaxie 500 e poi va via via irrobustendosi, fino a creare un inseguimento narcolettico che si trascina dalle parti dei Velvet Underground, mentre in sottofondo si fa strada l’organo, che prende definitivamente le coordinate della danza mentre l’incessante martellare sonoro mette in mostra una rabbia repressa destinata a trasfigurarsi in sogno, deliquio ondivago, fuga psicogena. Oramai la corsa è lanciata, e l’unico modo per interromperla è lasciarla inghiottire, in un marasma di rumori, dai gorghi onnivori dell’organo. In sei minuti e un’anticchia i Dadamah hanno scritto un inno immarcescibile, simbolo di un’etica musicale che avrà un peso preponderante per tutto il decennio.
Ma l’importanza di “This Is Not a Dream” non è certa tutta qui: ancora John Cale, Lou Reed, Sterling Morrison e Maureen Tucker ibridati con il cantato declamante e catacombale di Ian Curtis fanno capolino dietro “Papa Doc”; a tutto questo si aggiunge la voce femminile, tutta su un altro registro, a cozzare duramente, a sposarsi per contrasto e non per osmosi. La psichedelia mostra il suo lato più (tra)sognato in “Too Hot Too Dry”, dove una Patti Smith deforme si getta su una linea sonora dipanata e destinata alla reiterazione. La rabbia repressa è stavolta minata nella sua frastornante deflagrazione da meccanici suoni spaziali: il terraceo torna a fare i conti con l’immateriale, l’intangibile, l’ectoplasmatico – anche la voce è ora alquanto fantasmatica -, prima di piombare nel rumore assoluto, privo di coordinate precise. La forma canzone si mostra ancora una volta profondamente umorale nell’incedere di “Prove”, dove lo schema fisso della band – l’irruenza che si innesta, con i suoi nervi tesi e catatonici, su un tappeto musicale etereo e sussurrato – torna a far sentire la propria urgenza espressiva; urgenza che viene lievemente modificata nel ritmo di “Brian’s Children”, dove non c’è più un lento e inesorabile estremizzarsi dell’architettura del brano ma si passa senza esitazioni dalla breve declamazione solitaria iniziale a una danza stressata.
Nuovamente l’amore per il contrasto a farla da padrone in “High Tension House”, dove il tappeto sonoro, mai troppo snervato e più interessato a uno schizzo paesaggistico – paesaggio mentale, questo è ovvio, che non vi è nulla di naturalistico nel mondo (ri)creato da Montgomery – si incontra con il cantato disilluso e sconfitto di Montgomery. “Nicotine”, nella sua tensione sperimentatrice dimostra a chi ancora non fosse convinto da quanto ha sotto mano la grandezza dell’intero progetto musicale. Anche un brano apparentemente così a parte rispetto all’omogeneo distendersi sonoro del resto dell’album, rientra in realtà perfettamente nell’etica del suo creatore: il mondo incapace di pacificarsi, la ricerca di un punto d’incontro tra la materialità (in questo caso il sottofondo tribale percussivo) e il suo opposto (i soliti suoni cosmici, i riverberi inafferrabili), il gioco tra furore e calma, il cantato aulico ma indeciso e traballante, quasi un singhiozzo carico di eternità, sono la base portante di “This Is Not a Dream”, e qui esplodono con una forza innegabile.
C’è ancora tempo per darsi all’intreccio stonato di “High Time”, dove il riferimento già più volte riportato ai Joy Division diventa il corpus unico su cui fare affidamento e dove la spinta verso l’etereo acquista un valore vagamente sacrale, oppure per affinare il proprio gusto uditorio alla corte magmatica, iperreale e ovattante di “Scratch Sun”, o meglio ancora per lasciarsi trascinare al centro della pista da “Radio Brain”, con la band inguainata in abiti garage straziati dalla psichedelia e dai riverberi. Perché poi c’è solo un minuto scarso per affezionarsi alla circolarità giocosa di basso e chitarra di “Replicant Emotions” e poi ecco là che “This Is Not a Dream” se ne va, pronto ad accaparrarsi il delirio plaudente del pubblico. Perché Montgomery, Kim Pieters (basso), Janine Stagg (tastiere) e Peter Stapleton (batteria) meritano di entrare di diritto nella storia della musica, e di entraci dalla porta principale. All’uscita del loro capolavoro questo trattamento gli fu inspiegabilmente negato. Sarebbe ora di diffondere il verbo e riparare al madornale errore.
La più bella realtà del rock indipendente – date voi all’aggettivazione il valore che preferite, vedrete che risulterà sempre adatto – degli anni novanta non viene nè dagli USA, nè dalla Gran Bretagna, ma dalla sperduta Nuova Zelanda, provincia dell’impero. Ed è ora di farsene una ragione.








