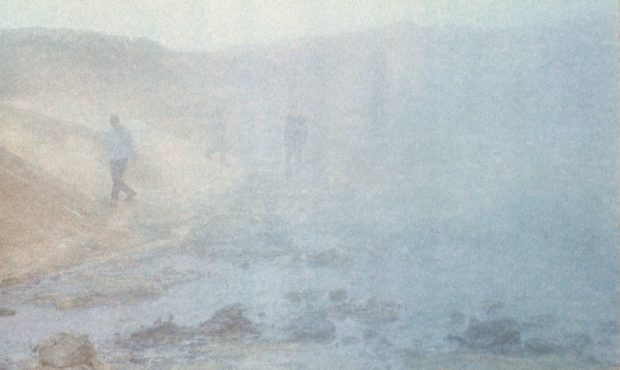“Blur”, il ventennale

“Blur” è il primo album indie degli Anni Zero. Lancio subito il sasso e nascondo la mano: è ovvio che questa definizione assolutamente sbilanciata e fuori fase è una provocazione. Ma lo è a ragion veduta. Si tratta di una veste diversa, maggiormente contaminata, che anche la musica inglese ha finito per indossare. Il 1997 è un anno di svolta e che ha in sé i semi del decennio – anzi in quel caso fu anche un millennio – a venire, e i suoni stavano cambiando. Lo fanno capire i quattro inglesi che pubblicano il loro album omonimo il 10 febbraio 1997, esattamente 20 anni fa, lasciando ad altri l’onere e l’onore di continuare il discorso (i Radiohead arrivarono a maggio con “OK Computer”).
I Blur perdono definitivamente l’aura di band da “Top Of The Pops” e fanno comprendere di essere fatti di altra pasta rispetto ai “cugini” – e sapete già di chi si parla – che invece anche in quell’anno continuano sulla strada puramente pop di “Be Here Now”.
Andiamo a riscoprire questo disco sottovalutato, canzone per canzone.
(Paolo Bardelli)
1. Beetlebum
“Beetlebum”, brano posto in apertura, è l’anello di congiunzione tra “The Great Escape” (1995) e “Blur” (1997): è l’unica canzone del disco che conserva ancora al proprio interno un forte senso delle melodie ed armonie pop – in linea, quindi, con le produzioni precedenti dei Blur – ma al tempo stesso si fa strada un nuovo modo di scrivere, più diretto, ruvido e puro. Si senta il tocco di chitarra ossessivo di Graham Coxon: la band improvvisa suonando insieme in studio come non accadeva da tempo, da anni ormai. Il titolo – che ricorda quello di un pezzo comico di Spike Jones and His City Slickers, “Beetlebomb” – fa riferimento, probabilmente, al modo di dire “chasing the beetle” (letteralmente, “dare la caccia allo scarabeo”): termine alternativo per “chasing the dragon” (ossia “drogarsi”), utilizzato per indicare il fumo di eroina (l’azione). Niente di misterioso (ormai), è lo stesso Damon Albarn ad aver spiegato, più volte, il tema della canzone: “è fondamentalmente sulle droghe. Non so cosa sia esattamente un Beetlebum. È soltanto una parola che cantavo quando suonavo la canzone a me stesso. Ho chiesto agli altri se dovevo cambiarlo ma hanno detto di no.” (da 1000 UK #1 Hits di Jon Kutner e Spencer Leigh).
(Monica Mazzoli)
2. Song 2
Se siete stati dei giovani ribelli durante gli Anni Novanta è doveroso citare Fifa World Cup 98 per cominciare l’analisi di “Song 2”. Questo perché probabilmente, per placare il vostro malessere adolescenziale, qualcuno ve lo ha regalato, senza sapere che “Song 2” (presente nella colonna sonora) avrebbe solo peggiorato le cose. Ancora bambina nel 1997, il ruolo di ribelle era ricoperto da mio cugino. Nel mio primitivismo musicale ho sempre avuto una predisposizione verso i chitarroni, e qualche videocassetta testimonia la mia ferocia nel chiedere la canzone “woo-woo” mentre il cugino imbronciato gioca alla playstation. Leggenda narra che “Song 2” nasca da una prova dei Blur in post sbronza con l’intento di deridere il grunge molto in voga negli Stati Uniti. Dopo vari intenti fallimentari di post produzione per addolcirla, la canzone rimase nuda e cruda come al principio.
Pur essendo indubitabilmente tra i più grandi successi della band, il brano non doveva far parte dell’album: venne fortemente voluto dalla distribuzione americana (chi l’avrebbe mai detto). Il titolo, inizialmente provvisorio, l’accompagnerà per sempre. Per gli amanti dei numeri e dei complotti: “Song 2” ovvero la seconda dell’album, il secondo singolo estratto, svetta al secondo posto in classifica negli UK, e dura 2 minuti e 2 secondi. Il video (Best Group video degli Mtv Music Adwards), diretto dalla maestra Sophie Muller, è un elegante espressione di disagio: la band in una stanza dalle pareti lynchane viene scaraventata da una parte all’altra per la potenza degli amplificatori. Il produttore Stephen Street ha poi svelato che quella potenza altro non è che la sovra-incisione della linea di basso. Lo stesso Alex James ne rimase sorpreso, ribadendo che non si ricorda affatto della sessione di registrazione.
Vincitrice di innumerevoli premi (Best British Single, and Best British Video per i British Adwards; Best track Ever per la BBC; etc etc), colonna sonora di pubblicità/film/videogames/serietv/lamiavita (Pentium II; Nissan; The Simpons; Doctor who etc etc), “Song 2” continua ad essere abusata (alla stregua di “Smells like Teen spirit”) nei più moderni “nostalgia” djset del globo. Il testo criptico, il riff pop ma anche grunge e sofferente fanno di “Song 2” un’eterna hit, a cui rimane il compito di seguire la vecchia e la nuova guardia di giovani ribelli.
(Tea Campus)
3. Country Sad Ballad Man
“Country Sad Ballad Man” ha l’onore ma anche la gran sfortuna di seguire in scaletta, come noto, “Beetlebum” e “Song 2”, ovvero le due canzoni più famose e (giustamente) celebrate del disco “Blur”, fra le perle senza dubbio ancor oggi più abbaglianti dell’intero catalogo bluriano. La qual circostanza tende a rendere il pezzo un episodio in apparenza minore, se non eccentrico.
Eppure questa ballata psichedelica stortignaccola e piacevolmente imperfetta, per non dire allucinata (qualcuno vi ritroverà probabilmente un vago tocco stralunato, degno di Kevin Ayers), si difende con una strambissima efficacia di marca tutta (o quasi) beckiana, smorzando gli shock elettrici del trionfale dittico d’apertura in un testo che intreccia la mirabolante biografia dell’effimera popstar anni Sessanta P. J. Proby (qui un utile e bell’articolo a riguardo) e proiezioni autobiografiche dello stesso Albarn.
Non nuoce a questo proposito riportare una dichiarazione di Graham Coxon (autore di riff e assoli che più pavementiami a tratti davvero non si può), che ricavo dalla biografia di Stuart Maconie (“3862 Days: The Official History of Blur”, 1999): “Mi piace riascoltare Country Sad Ballad Man . Ha una qualità di suono che mi fa stare bene. Quella sua autentica naturalezza, il fatto che il basso e la chitarra siano gli unici strumenti in totale disarmonia fra loro. Mi dà una sensazione di felicità. La perfezione può divenire a volte nauseante. Immagina che bello che qualcosa suoni bene anche quando è scordata. Mi rende felice”. Affermazioni facilmente estendibili al disco nel suo complesso, che peraltro ben chiariscono la natura del (cospicuo) apporto coxoniano alla ridefinizione dell’estetica dei Blur in quel per molti versi fatidico 1997.
(Francesco Giordani)
4. M.O.R.
“M.O.R. short for Middle of the Road”. Difatti, la quarta traccia di Blur si trova nel mezzo tra “Boys Keep Swinging” e “Fantastic Voyage” di David Bowie, entrambe contenute in “Lodger” (1979), una curiosità ormai pacifica, un brano che è un tributo al Duca Bianco.
La firma dei quattro di Colchester è quella più autentica e spontanea, il muro del suono della chitarra di Graham costruito ossessivamente nota dopo nota, il brano portato dalle dinamiche dirette e minimali di Rowntree, l’energia che va da dritto al sodo, di ragazzi che non hanno tempo da perdere nel mezzo della strada, tra gli altri e bassi della vita che un ragazzo vuole provare ad affrontare con una ragazza. Messaggio ribadito nel video, dove anagrammando i propri nomi, “Dan Abnormal” & co. si danno alla fuga, passamontagna in testa, introdotti da un’amabile musichetta da poliziottesco anni ’80.
(Francesco Fauci)
5. On Your Own
“On Your Own”, terzo singolo estratto da “Blur” e numero cinque della classifica inglese, è un ponte ideale tra passato e futuro del quartetto di stanza a Londra. Da una parte, i synth robotici di Damon Albarn e il suo cantato ai limiti del rap: lo stesso leader definirà il brano come un seme del progetto Gorillaz, e chissà che questo nome non derivi proprio dalla storpiatura di una parola nel ritornello (guerrilla). Dall’altra, uno sfavillante tessuto di chitarre in stile brit pop: Graham Coxon riappare vicino ai momenti migliori di “Parklife”. La mia canzone preferita del disco suona quasi come un mix da dinamite tra “Chemical World” e “Music is My Radar”.
“No psycho killer Hooligan guerilla I dream to riot Oh, you should try it
I’ll eat parole get gold card soul My joy of life is on a roll
And we’ll all be the same in the end Cause then you’re on your own”
(Matteo Maioli)
6. Theme from Retro
Se “Blur” è un album di svolta, è quando si arriva a “Theme from Retro” che si capisce che da lì non si torna più indietro. “Theme from Retro” è la loro “Interstellar Overdrive”, il partire per altri mondi come fu “2000 Light Years from Home” per i Rolling. I Blur diventano davvero quello che il loro nome significa, cioé sfumati, perché tutto si confonde in questa strumentale dal tempo shuffle con l’hammond che ci trascina in ambientazioni sconosciute, annebbiate come il retro (eh sì, appunto…) della copertina dell’album, dove i quattro camminano indistinti nelle brughiere islandesi. Non è ancora uno scomparire completamente, quello avverrà più tardi agli inizi del nuovo millennio e sarà un’altro gruppo inglese fondamentale a marcarlo, ma potrebbe essere considerata la rappresentazione di Albarn e soci di quella liquidità di cui oggi abbiamo contezza ma che allora poteva essere solo annusata: Internet si massificava un paio d’anni prima, e nel suono i Blur del 1997 tenevano – consciamente o inconsciamente – il passo, veloce e sempre più confuso, di quella modernità.
(Paolo Bardelli)
7. You’re So Great
Settima canzone dell’album è un intermezzo solitario: una chitarra acustica martoriata da uno strumming duro e tagliente e accompagnata dalle sovra-incisioni acide di una Telecaster, ma soprattutto dalla voce timida e sofferente di Graham Coxon (a quel tempo nel bel mezzo di una crisi depressiva legata all’abuso di alcol), che con l’ingenuità di un bambino lascia trasparire la sua personalità fragile in un testo che è a metà strada fra una dichiarazione d’amore e una richiesta disperata di aiuto:
“Sad, drunk and poorly/Wondering lost in a town full of frowns… And I see the light/When you tell me it’s ok!”
Il lavoro di smantellamento e decostruzione del brit-pop portato avanti in tutto l’album, passa anche – e soprattutto – attraverso canzoni come questa: una ballad malinconica e cantata con il cuore in mano, ma che grazie all’arrangiamento noisy/lo-fi riesce a restituire una sonorità rinnovata (che strizza l’occhio all’indie-rock d’oltreoceano, se si pensa per esempio agli Sparklehorse). Si tratta peraltro della prima canzone in assoluto scritta da Coxon, che da li in poi costruirà una rispettabile carriera da solista basata proprio su brani come questo.
(Gianpaolo Cherchi)
8. Death of a Party
Da molti considerato uno degli apici di un album pieno di pezzi memorabili, “Death of a party” rappresenta ancora oggi il brano che meglio racchiude l’anima più oscura dei Blur.
Un Damon Albarn mai così lamentoso e svogliato riesce a entrare sotto pelle come poche altre volte, accompagnato da una base strumentale apparentemente “fuori tema” (organetto e batteria funkeggiante in primis) ma tremendamente efficace.
Una menzione speciale va poi alle torbide liriche che sembrano parlarci di isolamento e alienazione. Pare che anni dopo la pubblicazione dell’album, i Blur abbiano dichiarato che la canzone trattasse di AIDS. Al di là delle possibili interpretazioni del testo, quello che resta è un pezzo che non ha paura di unire la spinta sperimentale riscontrabile in tutto il disco con la vena più intimista della band britannica.
(Stefano Solaro)
9. Chinese Bombs
L’intenzione di contaminare il britpop con il punk è chiara in “Chinese Bombs”, 90 secondi di composizione in cui cadono bombe cinesi, volano calci e si spengono le luci, proprio come nei locali di provincia o nei centri occupati dove (chiunque?) almeno una volta si è ritrovato in mezzo al pogo.
Ma l’Italia non è Hong Kong e l’unica speranza, più che un intervento di Bruce Lee, è quella di non finire come nella copertina dell’album.
Consiglio: provate a risentire l’intro di “Mayday” dei Libertines.
(Elena Abbati)
10. I’m Just a Killer for Your Love
Quando uscì il disco omonimo dei Blur, all’inizio del 1997, s’era capito sin dal primo singolo che sarebbe stato un album di cambiamento. E se in fondo i singoli tenevano conto di alcuni schemi classici, fu con gli altri brani che la band inglese fece capire la vera anima sonora di quel disco. Anima sonora creata in gran parte dalla chitarra di Coxon, che viaggia convinta verso territori lo-fi. “I’m Just a Killer For Your Love” si inserisce proprio su questa linea e la puntella guardando più al suono indipendente americano (Pavement su tutti), quasi dando un calcio al lato brit dei Blur, fino ad allora preponderante nella loro discografia.
(Francesco Melis)
11. Look Inside America
Non basta aggiungere qua e là tocchi sinistri, sporcare la melodia o modificare il substrato di una canzone. Quello che fa resistere alle intemperie del tempo un disco è la canzone stessa, o il contesto nelle quale essa è stata scritta, suonata o registrata. L’ omonimo “Blur”, nato strizzando l’occhio a milioni di generi in voga in quel periodo (su tutti il lo-fi di stampo slacker alla Beck, per intenderci), ha potuto conquistarsi un suo spazio vitale proprio perché sotto la coltre del periodo la forma canzone ha mantenuto solidità. “Look Inside America”, su tutte, è quella che più si distanzia dal disco, perché non si nasconde dietro overdrive, rintocchi di elettronica o sperimentalismi vari; ballata acustica che diventa elettrica, archi e arpe a dare colore agli assoli di Coxon, un ritornello che dice di guardare all’America senza esserne dipendente. Insomma, una canzone normale, nonché splendida, che fa capolino in un disco sperimentale che a sua volta è diventato un classico.
(Nicola Guerra)
12. Strange News from Another Star
Un brano che è tutto un equilibrio fragile, tra la realtà di una chitarra acustica e le atmosfere che conducono fuori corpo dei synth. Traspare l’inquieta sensazione di alienazione, di distanza dagli oggetti e dalle persone, come un volteggiare lentamente all’indietro senza possibilità di fermarsi, sussurrando a se stessi “I’m Lost, I’m Lost”. Il titolo della canzone è lo stesso di una raccolta di brevi racconti scritti da Herman Hesse a cavallo della Prima Guerra Mondiale, con il quale Albarn e soci condividono, probabilmente, l’incredulità che provano ad osservare la realtà in cui vivono, come se provenisse da altrove. Un traccia-esempio della capacità astrattiva e comunicativa allo stesso tempo dei Blur.
(Francesco Fauci)
13. Movin’ On
Quando ero in macchina, cercavo sempre di arrivare ad un semaforo rosso mentre partiva il folle assolo di synth: a quel punto alzavo lo stereo a manetta, tiravo giù i finestrini e guardavo i vicini di semaforo con occhi strabuzzanti e pogo incorporato sul sedile.
Se “Song 2” e “On Your Own” sono di tutti, “Movin’ on” è mia, è una diligenza lanciata a perdifiato sul selciato sconnesso del Deserto di Gila: un sobbalzo più forte degli altri sbalza il conducente, i cavalli impazziscono, i passeggeri vanno verso il deliquio.
(Max Cavassa)
14. Essex Dogs
Coi suoi sei minuti e passa (ma occhio alla strumentale ghost-track a strettissimo giro, che pare in realtà parte stessa del brano e porta il tutto a superare gli otto minuti), “Essex Dogs” è la “canzone” più lunga del disco. Ma la stranezza di questa composizione non si esaurisce certo soltanto nella sua singolare durata. Vista la collocazione verrebbe da considerare “Essex Dogs” un epilogo. Pensando tuttavia a come andarono poi le cose, possiamo oggi affermare che si trattò indubbiamente di un prologo.
Di fatto alla base di “Essex Dogs” c’è una poesia d’ispirazione apertamente autobiografica che Albarn lesse per la prima volta nel 1996 alle Olimpiadi di Poesia tenutesi presso l’illustre Royal Albert Hall di Londra. Versi e strofe come:
In this town cellular phones are hot with thieves/ In this town we all go to terminal pubs/ It helps us sweat out those angry bits of life/ From this town the English Army grind/ Their teeth to glass/ You’ll get kicked tonight/ Smell of puke and piss/ Smell of puke and piss on your stilettos
parlano fin troppo chiaro, nel descrivere le asprezze di una giovinezza tutt’altro che rassicurantemente borghese nella nativa Colchester. Ad ogni modo, quel che più sorprende non sono tanto o non solo le crudissime parole di Albarn, quanto piuttosto ciò che accade attorno alla sua ineffabile voce insolitamente recitante: un diluvio di rumori scombiccherati ma in qualche modo sinistramente coerenti, che oggi definiremmo probabilmente kraut-avant (ma riferimento evidente è anche il format bowiano del berlinese “Low”), fra i quali spiccano l’ormai famigerato effetto marmitta di motocicletta sortito dalla chitarra di Coxon, così come il crepitante aspirapolvere portatile azionato dal bassista Alex James attorno al minuto 2,30, proprio quando il tutto si avvolge in un’improvvisa quanto seducente aria trip-hop. Siffatto pastiche di musique concrète fu in realtà il risultato di una jam libera di una ventina di minuti, poi tagliata e cucita al computer dal produttore Stephen Street. Significativa anticipazione di quel che i Blur avrebbero poi radicalizzato in un metodo compositivo vero e proprio, in compagnia di William Orbit, nel controverso e avanguardistico album “13” del 1999.
(Francesco Giordani)