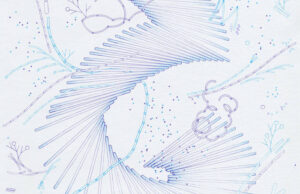BON IVER, “Bon Iver” (4AD/Jagjaguwar, 2011)
 Desolanti strade notturne che si avvolgono verso Fall Creek, Wisconsin da fantomatiche terre di frontiera (“Minnesota, WI”), città fantasma e non luoghi (“Hinnom, TX”, “Michicant”), infime circoscrizioni dell’Ohio (“Lisbon”), inesistenti città omonime di città straniere (“Perth”) o forse città vere e proprie (“Calgary”). Dopo l’EP “Blood Bank” e la collaborazione con Kanye West, l’invernale cantautore e compositore di Eau Claire, città che esiste davvero e si trova in Wisconsin, dà una svolta relazionale alla sua vita. Se l’intenso e sofferto “For Emma, Forever Ago” era stato partorito nella spietata solitudine di una capanna, l’eponimo “Bon Iver” vede la collaborazione di quasi venti amici e musicisti in uno studio costruito ad-hoc da Vernon in un ex-studio veterinario.
Desolanti strade notturne che si avvolgono verso Fall Creek, Wisconsin da fantomatiche terre di frontiera (“Minnesota, WI”), città fantasma e non luoghi (“Hinnom, TX”, “Michicant”), infime circoscrizioni dell’Ohio (“Lisbon”), inesistenti città omonime di città straniere (“Perth”) o forse città vere e proprie (“Calgary”). Dopo l’EP “Blood Bank” e la collaborazione con Kanye West, l’invernale cantautore e compositore di Eau Claire, città che esiste davvero e si trova in Wisconsin, dà una svolta relazionale alla sua vita. Se l’intenso e sofferto “For Emma, Forever Ago” era stato partorito nella spietata solitudine di una capanna, l’eponimo “Bon Iver” vede la collaborazione di quasi venti amici e musicisti in uno studio costruito ad-hoc da Vernon in un ex-studio veterinario.
La novità non è solo formale. Il suono Bon Iver si arricchisce di nuove angolature, sfumature, l’architettura degli arrangiamenti più barocca e variegata. Meno viscerale e immediato del clamoroso album d’esordio, necessità di più ascolti e di introspezioni notturne approfondite. La saga di uno di quei cantautori da immaginarsi tipicamente barbuti con camicia a quadri senza neanche aver cercato una foto su google, si discosta leggermente dal folk assumendo con sicurezza dei tratti da pop da camera. La calda voce si distende in strati e sovraincisioni ancora più avvolgenti. Scariche elettriche tra Wilco e Grizzly Bear incendiano inquietanti binari morti folk in “Perth” e “Minnesota,WI”. Echi, soffici orchestrazioni, archi veri e propri, colorano i surreali sfondi di una surreale strada senza uscita dal Wisconsin.
Nelle splendide “Calgary” e “Towers” emerge una dimensione corale che è quasi in paradosso con la natura da loner di Vernon. Sebbene lo spirito della seconda sgorghi da quelle sorgenti country che lo hanno sempre ispirato tra slide guitar e violini così tristi e rassegnati. L’anima folk dal piglio ineluttabilmente cinematografico prende piede in “Holocene” e “Michicant” dove è lo struggente timbro vocale a costruire i climax e gli inesorabili, dolorosi anti-climax.
Ci si avventura poi con discrezione in tortuosi sentieri cari a Phil Spector nella solenne e quasi compiaciuta “Beth/Rest” e nell’istantanea ultraterrena “Hinnon,TX”.
“Wash” è invece un suo marchio di fabbrica: decadente, intima e solitaria, con il valore aggiunto dell’arrangiamento d’archi dell’ambitissimo Rob Moose, membro dei My Brightest Diamond, già al lavoro al fianco di Sufjan Stevens, Antony and the Johnsons, The National e Arcade Fire.
Mai dismessi i panni di un Neil Young contemporaneo umile e introverso, nel nuovo viaggio verso i suoi riservatissimi non-luoghi, Justin Vernon si accompagna di luci e compagnie illusorie.
Fino a una nuova rassicurante solitudine.
82/100
(Piero Merola)