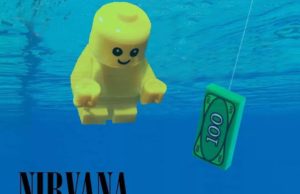MORRISSEY, Years Of Refusal (Decca / Polydor, 2009)
 Sappiamo tutti che Morrissey non è più un ragazzino, che i 50 sono davvero dietro l’angolo e che gli Smiths probabilmente non si riuniranno mai più. Non per questo ci si deve sentire autorizzati a trattare il suo ormai nono lavoro solista come l’album del grande vecchio nome che vive sulla rendita del passato e di cui non si spenderebbe una riga se si trattasse di un emergente. Per due motivi. Dopo la pausa sabbatica di sette anni che sembrava aver messo la parola fine sulla sua carriera, “You Are The Quarry” del 2004 e l’ultimo “Ringleader Of The Tormentors” hanno messo in luce una nuova vena per il tormentato mancuniano. In secondo luogo, a lui fregherebbe poco, gli sarebbe quasi di consolazione alla luce delle ultime voci di ritiro dalle scene.
Sappiamo tutti che Morrissey non è più un ragazzino, che i 50 sono davvero dietro l’angolo e che gli Smiths probabilmente non si riuniranno mai più. Non per questo ci si deve sentire autorizzati a trattare il suo ormai nono lavoro solista come l’album del grande vecchio nome che vive sulla rendita del passato e di cui non si spenderebbe una riga se si trattasse di un emergente. Per due motivi. Dopo la pausa sabbatica di sette anni che sembrava aver messo la parola fine sulla sua carriera, “You Are The Quarry” del 2004 e l’ultimo “Ringleader Of The Tormentors” hanno messo in luce una nuova vena per il tormentato mancuniano. In secondo luogo, a lui fregherebbe poco, gli sarebbe quasi di consolazione alla luce delle ultime voci di ritiro dalle scene.
Abbandonata Roma e le sue fascinazioni barocche, a tratti epiche, che avevano caratterizzato non poco il precedente album, si torna a Los Angeles. Alla produzione richiamato Jerry Finn, l’improbabile architetto della rinascita di “You Are The Quarry” scomparso pochi mesi dopo la fine delle registrazioni. Improbabile se si guarda alle sue più celebri collaborazioni (Green Day, Rancid, Sum41, AFI) più che all’effettivo lavoro sui suoni che aveva dato una nuova linfa a Morrissey. Ritmiche secche, chitarroni, e richiami tra power-rock e glam.
Ebbene, il quintetto iniziale è quanto di meglio si potrebbe chiedere per reagire a una di quelle mattine che preannunciano la classica giornata del cazzo. “Something Is Squeezing My Skull” è uno schiaffo in piena faccia, traumatico e rivitalizzante. “Mama Lay Softly On The Riverbed” ha un inizio dalle venature morriconiane (che vedono la loro apoteosi nel bizzarro western di “When I Last Spoke To Carol”) per poi spingersi tra pause rumorose e orchestrazioni decisive nel rendere il suono più vario ed emozionante. In “Black Cloud” emergono le mai defunte tendenze glam (da segnalare il cameo di Jeff Beck alla chitarra) e una vitalità che diventa esplosiva in “All You Need Is Me”. Canzonette rese interessanti per una brillantezza e una freschezza degna di quel “Vauxhall And I” che sembrava aver segnato l’acme creativo della sua esperienza solista. Sembrava. Perché quando si ascolta, o per meglio dire si subisce, il decadentismo tutto Smiths di “I’m Throwing My Arms Around Paris”, smentirsi è un dovere morale. Riuscire ancora a scrivere un brano così intenso e profondo condensato in soli due minuti e mezzo di musica gli viene ancora bene. Fin troppo bene. Come nell’altra struggente ballad orchestrale della raccolta, “You Were Good In Your Time”.
Meno bene nell’unico momento che convince veramente poco. “It’s Not Your Birthday Anymore” da una sussurrata serenata anni ‘80 sfocia in imprevedibili esplosioni emo, dal pathos troppo ostentato e pomposo. Troppo a stelle e strisce, e troppo poco british per farsene una ragione.
“That’s How People Grow Up” e “Sorry Doesn’t Help” seguono invece il filo conduttore interrottosi con la parentesi romana di tre anni fa. Assolutamente nulla di originale né di innovativo, ma la carica emotiva messa su dall’ispiratissima voce dell’ultimo degli inglesi dà un’identità a brani non straordinari. Costruiti comunque bene, con l’aiuto nella composizione dell’ex-chitarrista Alain Whyte e dagli attuali Jesse Tobias e Boz Boorer. Si pensi a “I’m OK By Myself” o, all’irrequieta “One Day Goodbye Will Be Farewell” con quel finale da cartolina del pop inglese della crisi di fine anni ’80, se solo trombe e orchestrazioni non venissero fuori per sottolineare come si tratti del Morrissey degli anni del rifiuto. Che poi è comunque il vecchio Morrissey quanto il Morrissey di ora e di sempre.
Basta concentrarsi sui testi, al solito imperdibili, per capire come in fondo il suo mondo non sia mai cambiato.