BRAINBLOODVOLUME No. 31
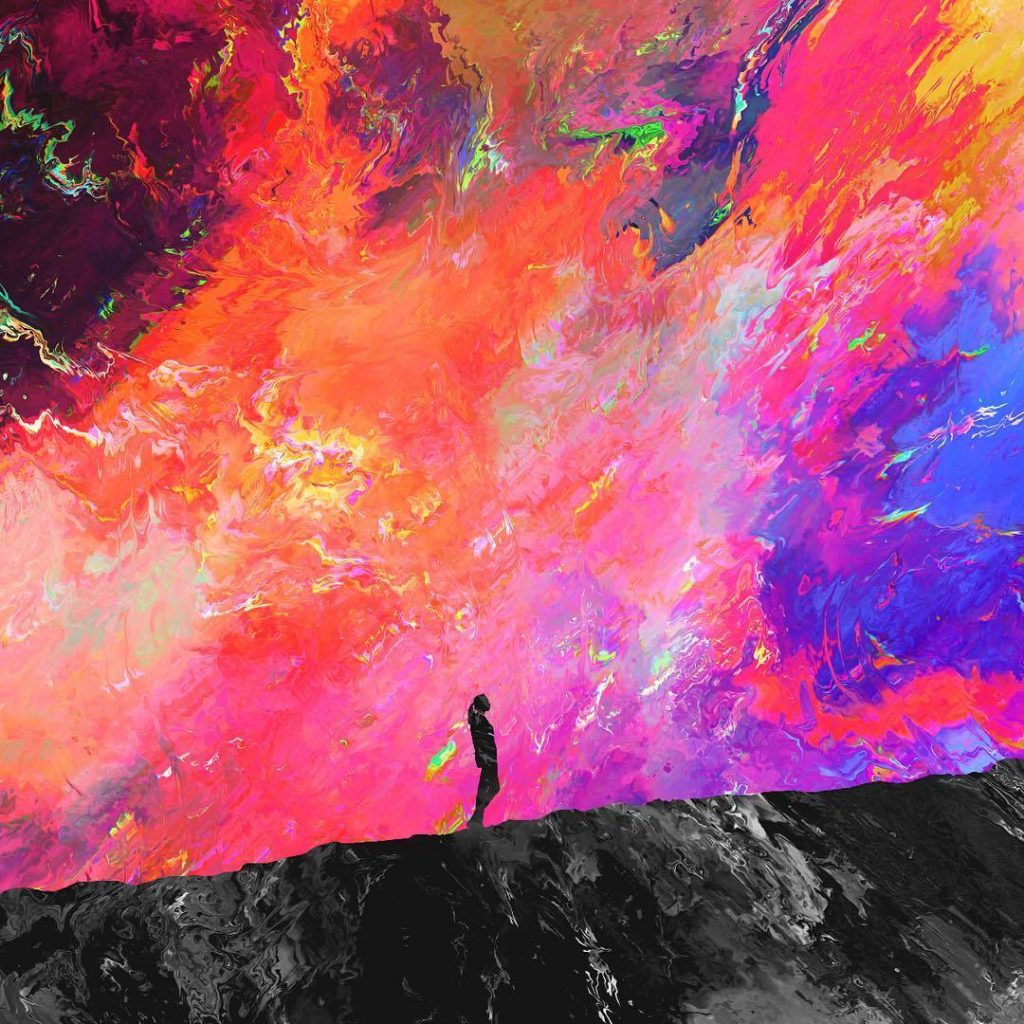
Cinque dischi di musica psichedelica, cinque.
COSMONAUTS, “Star 69” (Fuzz Club Records, 2019)

Negli ultimi tempi sono stato tutto sommato forse molto critico con le uscite marcate Fuzz Club Records, accusando, si fa per dire, da grande affezionato, la poca varietà delle proposte e una scarsa originalità: una piattezza che era in parte dovuta alla fine del boom della neo-psichedelia e un ritorno a format wave decadenti troppo minimali e ripetitivi. Quindi questo disco qui, come quello dei Gluts uscito pochi mesi fa, lo accolgo con grande favore. Sì, certo, niente di nuovo sotto al sole: voglio dire che qui anche non ci si deve aspettare una particolare originalità, ma “Star 69” dei Cosmonauts (da Fullerton, LA) è un disco che si sa muovere nel campo della musica psichedelica più avvicinabile in una maniera trasversale, riuscendo a essere al tempo stesso ascoltabile e convincente anche per chi ricerca suoni più tosti. Parlerei di un disco che dà una nuova linfa allo shoegaze e in effetti i rimandi intanto ai Ride, che sono un po’ dei punti di riferimento per chi voglia sapere di che cosa stiamo parlando, e poi ai Jesus & Mary Chain: la seconda parte dell’album contiene tutta una serie di ballads in perfetto stile fratelli Reid (“Molly On Glass”, “Humming”, “The Gold Line” e fino all’ultima traccia “Suburban Hearts”). Nella prima parte non mancano tuttavia elementi più astratti art e noise come le chitarre di “Seven Sisters” oppure “Wicked City” (un pezzo più complesso e che include tra nei suoi nove minuti di durata anche un intermezzo con quello stile di ballad decadente J&MC già accennato) e ancora “Heart of Texas”, dove lo stile è prossimo a quello A Place To Bury Strangers e accattivante come i bei sapori di una volta tipo VU, ma senza essere chic tipo “The VU and Nico” e questo è solo un bene per quanto mi riguarda. Mi è piaciuto molto: vigoroso e coinvolgente allo stesso tempo, godibile dall’inizio alla fine, riesce a fare emozionare e nei suoi momenti epici, regala momenti di godimento allo stato puro.
76/100
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, “Fishing for Fishies” (Flightless/ATO Records, 2019)

Il gruppo più schizoide e eclettico in circolazione, ci dimostra (ove fosse necessario) con questo primo disco pubblicato nel corso del 2019, che è capace di muoversi in una maniera agevole attraverso le asimmetrie del genere rock psichedelico e qui lo fa andando a rinnovare antiche tradizioni come quella del boogie e del blues. Proprio questi due generi sono infatti il cuore di “Fishing for Fishies” (Flightless/ATO Records), il ritorno del gruppo dopo la scorpacciata del 2017 e anticipato da un singolo contenente due pezzi dell’album, cioè, “Cyboogie”, una specie di boogie spaziale suonato con l’ausilio del vocoder e tastiere progressive acide anni settanta, con qualche sfumatura e una ironia che potrebbero persino fare il verso ai Rockets, e “Acarine”, forse il pezzo meno tipico rispetto al resto delle proposte di questa tornata, caratterizzato dalla ripetizione in maniera ossessiva e ripetuta della stessa sezione ritmica, come del resto vorrebbero i dettami del genere, e di nuovo l’uso di una effettistica della voce e intermezzi del suono dell’armonica e di riff di chitarra rock and roll, fino a una chiusura esplosiva di synth spaziali quasi disco anni settanta. Di volta in volta poi il gruppo ha sciorinato altri pezzi dell’album. Il leit-motiv è quello: il disco riprende gli schemi del boogie, ma lo fa ovviamente con il proprio stile e quella schizofrenia zappiana che abbiamo imparato a riconoscergli. “Fishing for Fishies” dimostra da subito le capacità istrioniche del gruppo, che è capace di passare nel corso di uno stesso pezzo da uno schema all’altro, ci mostra la sua natura trasversale e camaleontica, grazie anche di una formazione tecnica superiore e che non mancano di dimostrare. Vanno oltre gli schemi del progressive, i King Gizzard & The Lizard Wizard, perché comunque il loro approccio è qualche cosa di completamente nuovo rispetto agli anni d’oro del genere, e perché la loro natura non è seriosa, restano legati al format garage in maniera concettuale, e non hanno nessuna devozione a quelle forme di culto mistico degli anni settanta e cliché oramai fuori moda. Così se il pezzo introduttivo si può considerare come una semplice ballad, da “Boogieman Sam” si entra in medias res: si sparano quindi riff rock and roll blues elettrici, il suono dell’armonica imperversa in maniera incontrollata, il sound ha al tempo stesso le velleità di spostare l’attenzione dell’ascoltatore da un motivo all’altro, soprendendolo continuamente, ma anche di essere accattivante e ballabile come volevano suonare i Rolling Stones e qui in effetti non mancano né riferimenti al primo sound del gruppo di Mick Jagger e compagni, ma pure a quel rinnovamento dopo la pubblicazione ad esempio di “Black And Blue” (1976), un disco che ha nella sua verve e nella sua freschezza di suono, alcune somiglianze se non nel suono, almeno nella forza comunicativa di questo album, e l’entrata nel gruppo di Ronnie Wood. Aleggia ovviamente il fantasma John Lee Hooker da “Plastic Boogie” a “This Thing”, la stessa “Cyboogie”, ci sono di cori gospel rimescolati oppure resi in maniera sintetica, i riff rock and roll suonati a velocità supersonica e la alternanza con dimensioni lounge jazzate sofisticate e un uso dell’effettistica che non è mai fuori luogo. Sorprende che tutto riesca così bene a questo gruppo e il fatto è che i loro dischi hanno allo stesso tempo sia una natura cerebrale che qualche cosa che ti fa pensare alla improvvisazione più totale. C’è un amalgama forte che tiene questo combo unito e c’è molta voglia di fare e di sperimentare e mettersi continuamente in gioco. Sinceramente non si può che dare loro un voto molto alto anche questa volta. Continuano a divertirsi e a divertire.
80/100
PURLING HISS, “Interstellar Blue EP” (Drag City, 2019)

Bel dischetto dei Purling Hiss di Mike Polizze uscito su Drag City lo scorso luglio. Si intitola “Interstellar Blue” ed è composto da quattro tracce di rock psichedelia con una propensione cosmica che in particolare nella seconda parte, si vuole riferire a “Maggot Brain” dei Funkadelic, come se di quel sound potesse costituire una specie di rinnovamento e attualizzazione ai giorni nostri. In effetti non è propriamente così e diciamo che anche in questo caso appare mancare a questo gruppo quel “quid” per fare il salto di qualità definitivo e portare Mike e gli altri a venire stabilmente considerati tra i grandi. Dal mio punto manca una certa solidità pure rassicurante nel suono, che comunque non è imprevedibile ma forse eccessivamente fluido. Ciò non toglie ovviamente che il contenuto di questo EP sia comunque interessante. In buona sostanza il disco contiene “Useful Information”, che poi sarebbe il singolo, che si può considerare come un pezzo di garage psichedelia basato fondamentalmente sul suono della chitarra elettrica e un certo tono di ballad fatalista anni novanta, con qualche sfumature west-coast nirvaniana e accattivanti parti soliste semplici, ma funzionali; “Ostinato Jam” è una jam-session (appunto) di musica psichedelica acida di dieci minuti con un mucchio di effettistica e eco e riverberi, prettamente strumentale e basata su un giro di basso vigoroso e che ricorda ancora qualche cosa qui dei primi Nirvana di “Bleach”; “Naut” è un pezzo garage-psichedelico sparato a alta velocità molto anni settanta; la title-track, infine, anch’essa strumentale, sfocia in uno sperimentalismo psichedelico garage a bassa fedeltà, senza uso di percussioni, e un mucchio di effettistica e fuzz di chitarra e onde sonore che si alternano a costruzioni di arpeggi quasi pink-floydiani ma suonati in una maniera grezza e assolutamente istintiva. Un po’ di roba interessante insomma, ma tutto sommato all’atto di tirare le somme, nulla da segnalare.
60/100
MOTORPSYCHO, “The Crucible” (Rune Grammofon, 2019)

In trent’anni si può dire che i Motorpsycho abbiano esplorato il vasto campo del rock psichedelico in ogni suo aspetto e spingendosi fino a sperimentazioni che sono andate oltre i confini del genere “rock” e adottando un certo eclettismo che alla lunga li ha pure danneggiati sul piano della popolarità e della fidelizzazione del pubblico o comunque di chi compera i loro dischi. Dal 1989 ad oggi la band norvegese di Bent Saether e Hans Magnus Ryan ha subito anche diversi cambi di line-up, fatto collaborazioni diverse, eppure in qualche maniera acquisito comunque una sua identità unica e peculiare e che poi in questo continuo variare, resta ed è riconoscibile. Tra alti e bassi è comunque forse è comunque questo stile rock psichedelico anni sessanta-settanta e comunque massivo ad essere quello che più appare essere loro congeniale. Si potrà convenire quindi che nel caso di “The Crucible” ci troviamo davanti a un disco che è forse fuori moda, ma forse sono fuori moda proprio gli stessi Motorpsycho, ma se lo ascoltiamo possiamo pure considerare come in effetti non si tratti di un lavoro così ostico come questo potrebbe apparire. La pubblicazione è della Rune Grammofon, la label norvegese di Rune Kristoffersen (è uscito però anche su Stickman Records) e dell’etichetta ha comunque alcuni dei suoi aspetti più tipici, come quella sperimentazione noise free-form e avant-jazz che si fa sentire in maniera prepotente nella seconda parte di “Lux Aeterna” e tra le righe della title-crak. L’opera ha comunque un carattere effettivamente mastodontico, una solidità che potrebbe fare pensare a quella di gruppi anche più recenti tipo Arbouretum e che del resto pure sono liberamente ispirati alla cultura heavy-psych degli anni settanta. Ci sono sostanzialmente solo tre pezzi, quello più convenzionale è solito è “Psychotzar”, mentre “Lux Aeterna”, con la collaborazione della vocalist Susanna Wallumrod, ha connotati molto più free-form e sperimentali, raggiunge vette di rock psichedelico sinfonico, imperversa nel free-jazz, prima di ritornare alla coda finale e chiudere il lato A dell’album. La seconda parte è interamente occupata dalla title-track, una sontuosa suite di rock psichedelico dotato di una buona solidità e che per buoni venti minuti, riesce a tenere impegnato l’ascoltatore senza nessuna fatica. Il voto alla fine non è altissimo, forse perché non ci sono spunti di particolare ingegno che facciano emergere questo album dalla massa, ma “The Crucible” è tutt’altro che un flop e che anzi per gli ascoltatori più fidelizzati e legati a suoni anni settanta e “classici”, può essere uno degli ascolti più graditi di quest’anno. Manca una certa freschezza, ma non siamo neppure davanti al nulla totale tipo deserto oppure in alternativa a una specie di mare in tempesta: il suono di “The Crucible” è come il clima in Scandinavia durante l’inverno, quando la neve scende lenta ma pesante e inesorabile sopra le nostre teste, ma le strade su cui poggiamo i piedi sono solide e il nostro abbigliamento è adatto al contesto. Non abbiamo nulla di cui preoccuparci, dobbiamo solo andare.
68/100
PERE UBU, “The Long Goodbye” (Cherry Red, 2019)
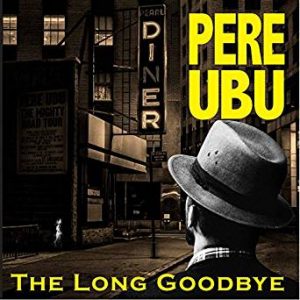
“The Long Goodbye” (1973) di Robert Altman è un film eccezionale. Voglio dire che a parte la grandezza dell’opera di Raymond Chandler, di cui ho letto meticolosamente l’intera produzione, trovandola assolutamente brillante, essenziale, perfetta, in questo caso specifico abbiamo il contributo di un grande regista nel rinnovare un mito e non solo mantenendo intaccata quella che ho voluto definire come perfezione, ma attualizzandola agli anni settanta e in un nuovo contesto, basandosi fondamentalmente sulla raccolta di lettere e appunti “Raymond Chandler Speaking” invece che il romanzo originale, creando una nuova figura di Philip Marlowe, qui interpretrato da Elliott Gould, uno degli attori feticcio di Altman e un attore che in quegli anni ha praticamente preso parte solo a film capolavoro. La colonna sonora del film è costruita su un tema di John Williams. La canzone dice, “It’s a long goodbye, and it happens everyday.” E in fondo che cosa è un “lungo addio” se non qualche cosa che ti trascini dietro per interi mesi, anni, magari per tutta la vita. Voglio intendere così in qualche modo il titolo di quello che a quanto pare, sarà l’ultimo album dei Pere Ubu. Il gruppo aveva avuto un brusco stop nel dicembre 2017: David Thomas aveva dato forfait per problemi di salute. Una lunga degenza aveva di fatto già messo fine all’attività del gruppo e questo album, intitolato appunto “The Long Goodbye” (Cherry Red) è stato presentato di fatto come il riepilogo di tutte le storie e le canzoni proposte dai Pere Ubu nel corso degli anni e sin dalla lontana fondazione del gruppo alla fine degli anni settanta. Chi lo sa, forse per Thomas questo è solo un altro “addio” dopo quello all’amico Peter Laughner, già suo compagno nei Rocket from the Tombs, poi collaboratore a Creem di Lester Bangs, oppure forse è sempre lo stesso, un lungo viaggio che chiaramente in ogni caso non si esaurisce con l’uscita di un disco che più che rappresentativo per il suo significato simbolico, che c’è, è semplicemente eccezionale. La cosa incredibile è in ogni caso il fatto che per l’ennesima volta ci troviamo davanti a un disco che ha una sorprendente potenza espressiva e che mostra una vena sperimentale che è coraggiosa, persino ardimentosa, ma che si risolve sempre in soluzioni brillanti, lasciando letteralmente di stucco l’ascoltatore. In questo senso, magari qualcuno potrà non essere d’accordo, ma questi Pere Ubu non valgano affatto meno che quelli degli esordi di “The Modern Dance” nel 1978. Arruolati come compagni di viaggio i fedelissimi Gagarini e Keith Moliné, più Michele Temple (basso), Darryl Boon (clarinetto), P.O. Jorgens (batteria e percussioni), Robert Wheeler (al lavoro ai synth assieme a Gagarin), in dieci tracce David Thomas riscrive un’altra volta la storia di quella che è l’avanguardia della musica post-punk. La sua voce inconfondibile mormora delle cantilene stridule, accentua il tono teatrale di ogni singola performance, che ci appare inevitabile come un vero e proprio happening, probabilmente il disco può dare sensazioni diverse a ogni ascolto e le canzoni possono sembrare ogni volta differente da quella precedente. La cosa incredibile è che mentre i pezzi sembrerebbero avere una loro “linea”, che è quella in generale seguita dalla voce, gli altri componenti del gruppo, creano dissonanze, dei veri e propri diversivi e che sembrerebbero andare in una direzione completamente differente. E invece c’è una specie di copione o comunque la incredibile capacità di muoversi tutti quanti assieme sullo stesso palcoscenico. Chiaramente c’è molta cultura beat in questo album, c’è Sir William Burroughs, ci sono cento anni di controcultura degli Stati Uniti d’America e ci sta la messa in atto del dadaismo secondo il manifesto già citato di “The Modern Dance”, ma ovviamente rivisto e arricchito dall’esperienza negli anni e messa in scena del copione di una vita e alla fine, quando forse cala il sipario, ti scende pure una lacrima. Poi però chi lo sa, perché il sipario cala, gli attori se ne vanno, ma il giorno dopo lo spettacolo si ripete e comunque il teatrante, quando lascia il teatro, lo sa che lo spettacolo, quello lì vero, se lo porta dietro e l’ultimo applauso è solo un pezzo del saluto che gli riserva l’infinità dell’esistenza.
86/100
Emiliano D’Aniello
Immagini: Dorian Legret.








