Gli album sottovalutati degli Anni ’10 – vol. 1
Come vi abbiamo anticipato ieri, iniziano qui su Kalporz una serie di speciali sugli anni ’10 che vorrebbero essere l’incipit di una discussione e analisi su questo periodo. Il primo focus è sui dischi sottovalutati degli anni ’10, che intendiamo in una accezione molto larga: gli album che al tempo furono poco considerati, quelli che passarono del tutto inosservati oppure i dischi che ci piacquero ma che non avremmo scommesso un cent sulla loro tenuta nel tempo.
Abbiamo quindi cercato di individuare – e ciascun scribacchino ha scelto il suo – un lp o un progetto che valga la pena recuperare e finanche portarsi avanti, negli anni ’20, assieme ai dischi indubbiamente importanti. Ma per quelli basta andarsi a sfogliare le classifiche di fine anno, e il gioco è fatto, mentre per altri – quelli che abbiamo cercato di individuare e che qui sotto sono in rigoroso ordine alfabetico – è stato il tempo trascorso ad essere galantuomo.
Lo speciale si compone di due volumi, questa è la prima parte, domani la seconda.
ALLO DARLIN’, “Europe” (Fortuna Pop!/Slumberland, 2012)
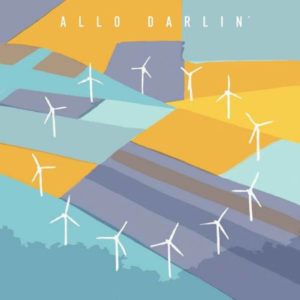 Il secondo album della band londinese guidata dalla vocalist e chitarrista di origini australiane Elizabeth Morris è semplicemente una delle cose da non dimenticare del decennio musicale che sta volgendo al termine. Meritevole, per la qualità della proposta, di ben più larga esposizione e successo. Uscito in un momento di grazia per Fortuna Pop!, “Europe” rappresenta un ideale anello di congiunzione fra i primi Belle And Sebastian e gli esponenti odierni del filone jangle quali Rolling Blackouts Coastal Fever e The Goon Sax. I brani al suo interno sono dei piccoli classici, “Neil Armstrong” getta subito le carte in tavola con la scintillante melodia di Paul Rains nelle vesti di novello Roger McGuinn mentre in “Wonderland” sembra di ascoltare un gruppo della Sarah Records cimentarsi in un tema folk-rock dei 10000 Maniacs. Indizi di grande eterogeneità: se da un lato i violini donano eleganza alla title track e a “Some People Say”, dall’altra il lullaby agrodolce “Tallulah” è quasi un home recording della sola Morris all’ukulele. “Capricornia” e “Northern Lights” vengono pubblicati come singoli di lancio, up-tempo buoni per il dancefloor di piccoli club e i cui videoclip ci mostrano gli Allo Darlin’ insieme tra sala prove, ricordi d’infanzia e una gita al mare. Quattro amici che hanno detto basta nel dicembre 2016 con un concerto alla Scala di Londra, “after eight years of playing, laughing, driving, dancing, singing and generally having the time of our lives”, pochi mesi dopo la notizia di cessata attività della label fondata da Sean Price nel 1995. Nel cuore di chi ama questa musica resta la stessa passione di chi ha generato esperienze memorabili.
Il secondo album della band londinese guidata dalla vocalist e chitarrista di origini australiane Elizabeth Morris è semplicemente una delle cose da non dimenticare del decennio musicale che sta volgendo al termine. Meritevole, per la qualità della proposta, di ben più larga esposizione e successo. Uscito in un momento di grazia per Fortuna Pop!, “Europe” rappresenta un ideale anello di congiunzione fra i primi Belle And Sebastian e gli esponenti odierni del filone jangle quali Rolling Blackouts Coastal Fever e The Goon Sax. I brani al suo interno sono dei piccoli classici, “Neil Armstrong” getta subito le carte in tavola con la scintillante melodia di Paul Rains nelle vesti di novello Roger McGuinn mentre in “Wonderland” sembra di ascoltare un gruppo della Sarah Records cimentarsi in un tema folk-rock dei 10000 Maniacs. Indizi di grande eterogeneità: se da un lato i violini donano eleganza alla title track e a “Some People Say”, dall’altra il lullaby agrodolce “Tallulah” è quasi un home recording della sola Morris all’ukulele. “Capricornia” e “Northern Lights” vengono pubblicati come singoli di lancio, up-tempo buoni per il dancefloor di piccoli club e i cui videoclip ci mostrano gli Allo Darlin’ insieme tra sala prove, ricordi d’infanzia e una gita al mare. Quattro amici che hanno detto basta nel dicembre 2016 con un concerto alla Scala di Londra, “after eight years of playing, laughing, driving, dancing, singing and generally having the time of our lives”, pochi mesi dopo la notizia di cessata attività della label fondata da Sean Price nel 1995. Nel cuore di chi ama questa musica resta la stessa passione di chi ha generato esperienze memorabili.
You Said It’s Hard To Believe
In The Age Of Aeroplanes In Miracles
But That Kind Of Brightness Never Appealed To Me
And I Was Already Headed For The Dance Floor
Allo Darlin’, “The Letter”
(Matteo Maioli)
BIG K.R.I.T., “Return of 4Eva” (2011)
 In un torrido weekend di luglio del 2012 mi trovavo a Chicago per seguire per Kalporz il Pitchfork Music Festival. Quell’edizione sarebbe diventata per molti aspetti un’edizione di svolta, riflesso o primo segnale di una svolta per la musica internazionale, in un’annata cruciale come quella del 2011-2012. La rinascita dell’hip hop e della black music, anni prima dell’esplosione della trap, iniziava a stravolgere linee editoriali, classifiche e gli stessi cartelloni dei festival. Dopo il cruciale “My Dark Twisted World Fantasy” di Kanye West sarebbero arrivati “Channel Orange” di Frank Ocean e “Good Kid, M.A.A.D City” di Kendrick Lamar. Quest’ultimo protagonista ai più sconosciuto di una performance pomeridiana che mi fece presagire cose fantastiche, proprio a quel Pitchfork Music Festival 2012. Tra gli altri ospiti di quell’edizione, oltre a Danny Brown, A$AP Rocky e Schoolboy Q, c’era il più lanciato BIG K.R.I.T., allora venticinquenne southern rapper dal Mississippi con il suo flow molto old school da crudo poeta metropolitano e un uso delle parole da fuoriclasse (vedi video). Qualche mese prima era uscito il suo secondo mixtape, “Return of 4Eva”, segnalato dai più attenti, ma il successo e l’importanza del disco col passare degli anni fu progressivamente eclissato dall’irripetibile esplosioni di talenti che dalla West Coast all’East Coast passando per Chicago, Atlanta e le nuove capitali del rap, hanno trasformato l’hip hop nel genere traversalmente più popolare e seguito del decennio.
In un torrido weekend di luglio del 2012 mi trovavo a Chicago per seguire per Kalporz il Pitchfork Music Festival. Quell’edizione sarebbe diventata per molti aspetti un’edizione di svolta, riflesso o primo segnale di una svolta per la musica internazionale, in un’annata cruciale come quella del 2011-2012. La rinascita dell’hip hop e della black music, anni prima dell’esplosione della trap, iniziava a stravolgere linee editoriali, classifiche e gli stessi cartelloni dei festival. Dopo il cruciale “My Dark Twisted World Fantasy” di Kanye West sarebbero arrivati “Channel Orange” di Frank Ocean e “Good Kid, M.A.A.D City” di Kendrick Lamar. Quest’ultimo protagonista ai più sconosciuto di una performance pomeridiana che mi fece presagire cose fantastiche, proprio a quel Pitchfork Music Festival 2012. Tra gli altri ospiti di quell’edizione, oltre a Danny Brown, A$AP Rocky e Schoolboy Q, c’era il più lanciato BIG K.R.I.T., allora venticinquenne southern rapper dal Mississippi con il suo flow molto old school da crudo poeta metropolitano e un uso delle parole da fuoriclasse (vedi video). Qualche mese prima era uscito il suo secondo mixtape, “Return of 4Eva”, segnalato dai più attenti, ma il successo e l’importanza del disco col passare degli anni fu progressivamente eclissato dall’irripetibile esplosioni di talenti che dalla West Coast all’East Coast passando per Chicago, Atlanta e le nuove capitali del rap, hanno trasformato l’hip hop nel genere traversalmente più popolare e seguito del decennio.
Tuttora quel mixtape di BIG K.R.I.T. è un pugno nello stomaco, una lezione di rap di una delle voci più ingiustamente sottovalutate del decennio. C’è chi ha parlato di erede degli Outkast, chi di risposta del sud a Kendrick Lamar. Ciò che è certo è che non trovate “Return of 4Eva” su Spotify. Lo trovate scaricabile gratuitamente qui. Oppure accontentatevi di questa playlist Youtube che racconta 75 dei minuti più intensi e true dell’hip hop degli anni Dieci.
(Piero Merola)
BONOBO, “Black Sands” (Ninja Tune, 2010)
 “Black Sands” è il lavoro che rappresenta il salto di qualità per Simon Green, aka Bonobo, dj e produttore che a partire dal 2000 aveva già messo in fila tre buoni album come “Animal Magic”, “Dial ‘M’ For Monkey” e “Days To Come”.
“Black Sands” è il lavoro che rappresenta il salto di qualità per Simon Green, aka Bonobo, dj e produttore che a partire dal 2000 aveva già messo in fila tre buoni album come “Animal Magic”, “Dial ‘M’ For Monkey” e “Days To Come”.
Dodici tracce, quelle di “Balck Sands”, in cui si percepisce la magia di un suono che diventa personale: downtempo, jazz, trip hop, soul, echi e rumori del sottobosco appaiono come elementi costitutivi di un album che si fa ascoltare all’infinito. L’eleganza si materializza con la voce di Adreya Triana, su cui Green cuce “Eyesdown”, “The Keeper” e “Stay the Same”.
Ma “Back Sands” non fu accolto come qualcosa di speciale, in un periodo in cui la formula che dava prosecuzione al filone trip hop, seppur con qualche tentativo di innovazione, appariva abusata e mostrava la corda.
Diversamente, come i vini migliori, “Balck Sands” è sopravvissuto al trascorrere di quasi un decennio e, rispetto alla massa dei molti album di quel periodo, suona ancora attuale.
Tra i gioielli nascosti del catalogo Ninja Tune.
(Tommaso Artioli)
DIRTY BEACHES, la trilogia su Zoo Music (2011, 2013, 2014)
“Badlands” (Zoo Music, 2011), “Drifters/ Love Is The Devil” (Zoo Music, 2013), “Stateless” (Zoo Music, 2014)
 Qui, più che di disco dimenticato, trattasi di mancanza di attenzione verso un progetto a lungo raggio. Un viaggio che utilizza i Suicide come mezzo per presentarsi al mondo (a chi non piacciono i Suicide?) passando a dare dei piccoli schiaffetti sul culo di Re Presley (a chi non piace Elvis?) fino a dipanarsi nella nebbia più fitta della sperimentazione (ecco, forse la nebbia non a tutti piace). Alex Zhang Hungtai, classe 1980, nato a Taipei, Canadese con il mondo come fissa dimora, si presenta al pubblico indie (sempre in cerca di sensazionali verità che durino un battito d’ali) con un disco bomba quale “Badlands” datato 2011. Elvis si diceva, Suicide, verissimo, ma anche rumore e brandelli di cinema dimenticato, amori al neon e ballate ritrovate in grammofoni sotto il livello del mare (“True Blue” a tal proposito è un pezzo disegnato vecchio che è vivo per quanto è reale). Applausi a scena aperta e poi via cercare qualcosa di nuovo. Mr. Spiagge Sporche torna solo due anni dopo, sempre sotto Zoo Music Records, per scrivere il cuore di una trilogia che in molti hanno deciso di non seguire. “Drifters/ Love Is The Devil” del 2013 è un doppio disco, è la continuazione di un viaggio iniziato nel passato che prova a vivere questo presente incerto. Sintetico, sincopato, incurante e spavaldo ma anche fragile, figlio di nevrosi collettive, è blues urbano coperto di melma, cupo, isolato dal mondo e incapace di guardare nella direzione giusta. Ieri c’era Elvis e Mr. Zhang aveva un santino che un emanava un barlume di speranza. Oggi tutto è così asettico; lui è spaventato e riversa così le sue paure in un folle diario metropolitano. Città e luoghi che cerca di conoscere ma che probabilmente non lo rappresentano. Arriva quindi il momento di lasciare questo schifoso presente (descritto in questi due dischi in maniera agghiacciante) per buttarsi nel futuro. Ecco, forse proprio “Drifters/ Love Is The Devil” è l’anima dimenticata del progetto Dirty Beaches. Ero a Los Angeles in quel periodo e la società americana allo sbando aveva per me una adeguata e vivida colonna sonora. Lasciai il disco in stand-by in attesa di leggerne il finale. Che arrivò l’anno successivo. “Stateless” non è il futuro. È un luogo dove rifugiarsi dopo aver visto tutto quell’orrore, è un’oasi di pace, la fine del viaggio, un finale non scritto che preferisce perdersi nel cosmo invece di ricongiungere il cerchio. Inaspettato, per questo stupefacente. Ambient che si arrampica in cielo. Strumentale. Si chiude il sipario su uno dei progetti più interessanti degli anni 10. Peccato che a noi continui a piacere il bacino e il sedere di Elvis.
Qui, più che di disco dimenticato, trattasi di mancanza di attenzione verso un progetto a lungo raggio. Un viaggio che utilizza i Suicide come mezzo per presentarsi al mondo (a chi non piacciono i Suicide?) passando a dare dei piccoli schiaffetti sul culo di Re Presley (a chi non piace Elvis?) fino a dipanarsi nella nebbia più fitta della sperimentazione (ecco, forse la nebbia non a tutti piace). Alex Zhang Hungtai, classe 1980, nato a Taipei, Canadese con il mondo come fissa dimora, si presenta al pubblico indie (sempre in cerca di sensazionali verità che durino un battito d’ali) con un disco bomba quale “Badlands” datato 2011. Elvis si diceva, Suicide, verissimo, ma anche rumore e brandelli di cinema dimenticato, amori al neon e ballate ritrovate in grammofoni sotto il livello del mare (“True Blue” a tal proposito è un pezzo disegnato vecchio che è vivo per quanto è reale). Applausi a scena aperta e poi via cercare qualcosa di nuovo. Mr. Spiagge Sporche torna solo due anni dopo, sempre sotto Zoo Music Records, per scrivere il cuore di una trilogia che in molti hanno deciso di non seguire. “Drifters/ Love Is The Devil” del 2013 è un doppio disco, è la continuazione di un viaggio iniziato nel passato che prova a vivere questo presente incerto. Sintetico, sincopato, incurante e spavaldo ma anche fragile, figlio di nevrosi collettive, è blues urbano coperto di melma, cupo, isolato dal mondo e incapace di guardare nella direzione giusta. Ieri c’era Elvis e Mr. Zhang aveva un santino che un emanava un barlume di speranza. Oggi tutto è così asettico; lui è spaventato e riversa così le sue paure in un folle diario metropolitano. Città e luoghi che cerca di conoscere ma che probabilmente non lo rappresentano. Arriva quindi il momento di lasciare questo schifoso presente (descritto in questi due dischi in maniera agghiacciante) per buttarsi nel futuro. Ecco, forse proprio “Drifters/ Love Is The Devil” è l’anima dimenticata del progetto Dirty Beaches. Ero a Los Angeles in quel periodo e la società americana allo sbando aveva per me una adeguata e vivida colonna sonora. Lasciai il disco in stand-by in attesa di leggerne il finale. Che arrivò l’anno successivo. “Stateless” non è il futuro. È un luogo dove rifugiarsi dopo aver visto tutto quell’orrore, è un’oasi di pace, la fine del viaggio, un finale non scritto che preferisce perdersi nel cosmo invece di ricongiungere il cerchio. Inaspettato, per questo stupefacente. Ambient che si arrampica in cielo. Strumentale. Si chiude il sipario su uno dei progetti più interessanti degli anni 10. Peccato che a noi continui a piacere il bacino e il sedere di Elvis.
(Nicola Guerra)
DM STITH, “Pigeonheart” (Octaves/ Outset Recording, 2016)
 “Andateci piano con me”, dice David nella title-track e rimanda alla splendida fragilità diafana che anima il synth folk che si sprigiona in “Pigeonheart”. Due dischi soltanto, finora: nel 2009 “Heavy Ghost”, nel 2016 questo altro gran lavoro. Commenti positivi, buone recensioni, ma nulla più per il protetto di Sufjan Stevens che meriterebbe tanta attenzione e considerazione quanto quella, giustamente, accordata al suo “protettore”. Dalle eteree pastorali folk dell’esordio si passa ad esperimenti elettro-acustici tra Bon Iver e Julia Holter, ravvivati da beats sintetici prodotti dallo storico Ben Hillier. La vocalità del titolare è al centro di tutto, senza vocoder o altri trucchetti, atmosfere crepuscolari, epicità soave da Grizzly Bear kraut, tribalità da desertiche inquietudini, lirico e onirico, DM va oltre Mark Hollis o gli esperimenti solisti di Yorke. E altro che andarci piano caro, capolavoro e stop. Riascoltatelo anche con il senno di poi.
“Andateci piano con me”, dice David nella title-track e rimanda alla splendida fragilità diafana che anima il synth folk che si sprigiona in “Pigeonheart”. Due dischi soltanto, finora: nel 2009 “Heavy Ghost”, nel 2016 questo altro gran lavoro. Commenti positivi, buone recensioni, ma nulla più per il protetto di Sufjan Stevens che meriterebbe tanta attenzione e considerazione quanto quella, giustamente, accordata al suo “protettore”. Dalle eteree pastorali folk dell’esordio si passa ad esperimenti elettro-acustici tra Bon Iver e Julia Holter, ravvivati da beats sintetici prodotti dallo storico Ben Hillier. La vocalità del titolare è al centro di tutto, senza vocoder o altri trucchetti, atmosfere crepuscolari, epicità soave da Grizzly Bear kraut, tribalità da desertiche inquietudini, lirico e onirico, DM va oltre Mark Hollis o gli esperimenti solisti di Yorke. E altro che andarci piano caro, capolavoro e stop. Riascoltatelo anche con il senno di poi.
(Giampaolo Cristofaro)
FOXYGEN, “…And Star Power”, (Jagjaguwar, 2014)
 Una risposta al contemporaneo e omogeneo modo di fare musica, un disco che si appresta a celebrare 5 anni di vita, ma che ancora non ha trovato una giustizia, e forse nemmeno una dimensione ben definita, ma va bene così perchè “…And Star Power” è una quintessenza di multi-dimensionalità.
Una risposta al contemporaneo e omogeneo modo di fare musica, un disco che si appresta a celebrare 5 anni di vita, ma che ancora non ha trovato una giustizia, e forse nemmeno una dimensione ben definita, ma va bene così perchè “…And Star Power” è una quintessenza di multi-dimensionalità.
Un lavoro ingombrante, prolisso, ma che proprio grazie alla sua mancanza di grazia esprime una moltitudine. Il disco è uno studio musicale a cielo aperto, si intreccia in overture, passaggi brevi, ricurvi e densi di accenti, riff e ridondanze. Un disco barocco, ma non per puro estetismo, piuttosto per necessità, per ricerca. “…And Star Power” è come uno studio uscito su Science o su Nature, è un passaggio necessario per il progresso, per l’oltre. È un anello di congiunzione, che non può non essere citato, ricordato e riascoltato.
Il disco è disturbante come la stessa attitude in live dei Foxygen, che sono esattamente come si sentono in album: autodistruttivi, eccessivi e senza troppe regole.
82 minuti e 24 tracce, un compendio di soft rock che spesso viene sballottato in sezioni di fiati, riff hard rock e un attitude punkeggiante. Una corrente elettrica in continuo movimento, è come trovarsi davanti un Paul McCartney attaccato ad una batteria per l’auto che per forza di cose deve scaricarci, con poco garbo, le sue emozioni addosso.
La band è sempre stata accusata di vivere sulle spalle di un revivalismo dei ‘60-’70 e, probabilmente, possiamo dire che i dischi dei Foxygen non fanno nulla per invertire questi clichè e modi di dire, ormai cicatrizzati nelle parole di molti critici.
Il disco non deve perdersi in una lettura eccessivamente creativa, perché i Foxygen hanno il limite/pregio di riportare in vita pezzi di passato. Il punto però è proprio il tono in cui questo viene fatto, non c’è un effetto parodia o una brutta copia ma, in particolare in questo disco, c’è una spinta a vivere, a rendere vitale e attuale un suono, una sensazione che magari potevamo sentire nei Grateful Dead.
Il lavoro dei Foxygen ha tanto, in termini di approccio, in comune con il più attuale disco di White Fence, dove infatti la ricerca di un sound non perde mai la rotta e cavalca binari forse prevedibili, ma ugualmente affascinanti.
Il disco è importante da ricordare perché spiega due concetti fondamentali e fondanti: il primo è che avere una spinta revivalistica del genere, non significa essere fedeli ad una teocrazia, ma indica la capacità di rinnovare, proporre, riscoprire e portare in chiave personale quello che è un sound esacerbato dal tempo; il secondo è che un disco lungo, prolisso e impegnativo sarà anche fuori dalla logica della discografia contemporanea, ma può offrire spunti, sensazioni e intuizioni più tangibili, profonde.
“…And Star Power” è un manifesto nascosto. L’immediatezza instagrammabile non è un concetto caro ai Foxygen. 82 minuti però sono un buonissimo minutaggio per capire che in “…A Star Power” non c’è l’attaccamento a Neil Young, ai Beatles, a Mick Jagger, ma c’è la celebrazione di un’estetica DIY, sporca e poco fruibile, ma estremamente affascinante.
(Gianluigi Marsibilio)
HTRK, “Psychic 9-5 Club” (Ghostly International, 2014)
 Per la band australiana (poi accasatasi a Berlino e a Londra) gli anni ’10 iniziavano con la morte di Sean Stewart, bassista. Era il 18 marzo 2010 e gli HTRK, fin lì attivi come trio non si fermarono. Dopo “Marry Me Tonight” (2009) arrivò “Work (Work, Work)”, pubblicato nel 2011 già come duo ma con materiale dei tre. Forse, però, il fascino di “Psychic 9-5 Club” (2014) andò oltre quello dei primi lavori. Suoni dilatati, passioni senza respiro, elettronica che non sapeva di esserlo. Fu anche il disco in cui il tratto industriale si incastrò meglio con la dimessa sensualità pop di Jonnine Standish e con quella sensibilità melodica ancora un po’ sporca. Era punk al rallentatore, pop sedato, febbre, febbre alta. C’erano dentro una smania e una tensione insopportabili e bellissime. Nella storia degli HTRK c’era stato l’appassionato endorsement da parte di Sasha Grey ma soprattutto la collaborazione assidua con l’icona Rowland S. Howard, fino ai suoi ultimi mesi di vita. C’erano da una parte il buio a fare da perenne sfondo e da un’altra la vitalità che bruciava in primo piano. O forse era il contrario. È stato tutto molto veloce: paradosso di una band invischiata nella sua morbosa e magica lentezza. Grosso modo, poi, quel “sentire” lì lo abbiamo apprezzato ma sui dischi di altri. Forse non era esattamente il tempo giusto. Troppo lento, troppo veloce.
Per la band australiana (poi accasatasi a Berlino e a Londra) gli anni ’10 iniziavano con la morte di Sean Stewart, bassista. Era il 18 marzo 2010 e gli HTRK, fin lì attivi come trio non si fermarono. Dopo “Marry Me Tonight” (2009) arrivò “Work (Work, Work)”, pubblicato nel 2011 già come duo ma con materiale dei tre. Forse, però, il fascino di “Psychic 9-5 Club” (2014) andò oltre quello dei primi lavori. Suoni dilatati, passioni senza respiro, elettronica che non sapeva di esserlo. Fu anche il disco in cui il tratto industriale si incastrò meglio con la dimessa sensualità pop di Jonnine Standish e con quella sensibilità melodica ancora un po’ sporca. Era punk al rallentatore, pop sedato, febbre, febbre alta. C’erano dentro una smania e una tensione insopportabili e bellissime. Nella storia degli HTRK c’era stato l’appassionato endorsement da parte di Sasha Grey ma soprattutto la collaborazione assidua con l’icona Rowland S. Howard, fino ai suoi ultimi mesi di vita. C’erano da una parte il buio a fare da perenne sfondo e da un’altra la vitalità che bruciava in primo piano. O forse era il contrario. È stato tutto molto veloce: paradosso di una band invischiata nella sua morbosa e magica lentezza. Grosso modo, poi, quel “sentire” lì lo abbiamo apprezzato ma sui dischi di altri. Forse non era esattamente il tempo giusto. Troppo lento, troppo veloce.
(Marco Bachini)
JOHN SOUTHWORTH, “Niagara” (Tin Angel Records, 2014)
 La storia di “Niagara” del songwriter anglo-canadese John Southworth è curiosa : un concept album doppio – complesso ma non pretenzioso – di canzoni di confine tra Canada ed USA, ignorato dai Polaris Music Prize canadesi (premio musicale) ma apprezzato dal National Post (giornale di Toronto), trova maggior fortuna in Europa, recensito con ottimi voti da riviste britanniche come Mojo, Uncut e nominato da Rolling Stone Germania miglior disco del 2014.
La storia di “Niagara” del songwriter anglo-canadese John Southworth è curiosa : un concept album doppio – complesso ma non pretenzioso – di canzoni di confine tra Canada ed USA, ignorato dai Polaris Music Prize canadesi (premio musicale) ma apprezzato dal National Post (giornale di Toronto), trova maggior fortuna in Europa, recensito con ottimi voti da riviste britanniche come Mojo, Uncut e nominato da Rolling Stone Germania miglior disco del 2014.
Un caso più unico che raro, qualsiasi sia il punto di vista : un lavoro discografico, pensato come fosse un libro di due volumi – uno “canadese”, uno “americano – di immagini narrative e poetiche, fotografie di due scenari geografici ed umani, diversi ma forse a volte anche simili.
Si parla, comunque, di canzoni, che diventano (quasi) i capitoli di un romanzo in musica : i venti brani con eleganza e raffinatezza attraversano stili, linguaggi – pop, country e jazz – e raccontano storie sospese nel tempo, tra luci ed ombre.
(Monica Mazzoli)









