La Top 7 dei dischi della Sub Pop usciti tra 1993 e 1997
Continuiamo la nostra cavalcata lungo i lustri della Sub Pop, e analizziamo – dopo quello tra 2008 e 2012 – il periodo che va tra il 1993 e il 1997, identificando sette album importanti dell’etichetta di Seattle. Sette scelte elencate in ordine cronologico
#1. AFGHAN WHIGS, “Gentlemen” (1993)
 Gli Afghan Whigs sono stati sicuramente uno dei gruppi migliori dell’inizio degli anni novanta e il loro momento migliore (il gruppo è attivo ancora oggi) si lega in maniera indissolubile all’esperienza con la Sub Pop Records. La doppietta “Congregation” (1992) + il disco capolavoro “Gentlemen” (1993) inaugurerà una fortunata fase che proseguirà anche con i due successivi dischi “Black Love” e “1965” prima dello scioglimento del gruppo e che si è riunito solo nell’ultimo decennio, dopo che il frontman Greg Dulli si è disimpegnato nel frattempo in una moltitudine di progetti diversi e anche dando un contributo rilevante alla storia del gruppo più importante del rock italiano, cioè gli Afterhours, di cui è stato compagno di viaggio per tutto il periodo alla metà dello scorso decennio, marcando il sound di “Ballate per piccole iene”, portando il gruppo in tour negli USA e coinvolgendo Manuel Agnelli nel suo progetto Twilight Singers. Furono proprio gli Afterhours a suonare come gruppo di sostegno nel primo storico concerto dei Gutter Twins di Dulli e del suo compagno Mark Lanegan a Roma. Questo succedeva più di dieci anni fa. Sembra ieri.
Gli Afghan Whigs sono stati sicuramente uno dei gruppi migliori dell’inizio degli anni novanta e il loro momento migliore (il gruppo è attivo ancora oggi) si lega in maniera indissolubile all’esperienza con la Sub Pop Records. La doppietta “Congregation” (1992) + il disco capolavoro “Gentlemen” (1993) inaugurerà una fortunata fase che proseguirà anche con i due successivi dischi “Black Love” e “1965” prima dello scioglimento del gruppo e che si è riunito solo nell’ultimo decennio, dopo che il frontman Greg Dulli si è disimpegnato nel frattempo in una moltitudine di progetti diversi e anche dando un contributo rilevante alla storia del gruppo più importante del rock italiano, cioè gli Afterhours, di cui è stato compagno di viaggio per tutto il periodo alla metà dello scorso decennio, marcando il sound di “Ballate per piccole iene”, portando il gruppo in tour negli USA e coinvolgendo Manuel Agnelli nel suo progetto Twilight Singers. Furono proprio gli Afterhours a suonare come gruppo di sostegno nel primo storico concerto dei Gutter Twins di Dulli e del suo compagno Mark Lanegan a Roma. Questo succedeva più di dieci anni fa. Sembra ieri.
“Gentlemen” è sicuramente uno dei dischi che ho ascoltato di più nel corso degli anni della mia giovinezza, ma che ancora oggi rimetto su con piacere. Un paio di canzoni (in particolare “When We Two Parted”) per quanto mi riguarda sono veramente dei grandi pezzi e dove la scrittura primitiva, ma efficace di Greg Dulli rende al massimo della sua potenzialità. Il gruppo, va detto, cercò da subito di guadagnarsi la fama di “ragazzi cattivi”. Circolavano storie secondo le quali il gruppo di Cincinnati, Ohio si fosse formato in prigione; sicuramente Greg Dulli non è mai stato una persona molto affabile. Oggi sembra un grosso orco pieno di alcol e che fuma una sigaretta dopo l’altra e molto spesso siamo proprio quello che sembriamo. Sicuramente definirlo un cantautore elegante e con lo stesso stile di un altro vocalist ombroso come Nick Cave è assolutamente fuori luogo. La scrittura di Dulli è più viscerale, sicuramente autentica, perché naif ma allo stesso tempo desiderosa di andare a fondo nell’animo della persona e scoprendone i suoi stessi limiti e contraddizioni. “Gentlemen” è così sostanzialmente un disco di canzoni d’amore, inteso in senso fisico, materiale e dove sia il contatto che la lontananza sono impregnati di tensioni emotive e incomprensioni, più vere e proprie manifestazioni di disagio che amore spassionato oppure “sesso”, come si vuole raccontare di solito.
Il sound è sicuramente molto particolare (e non ha niente a che fare con il genere grunge, cui il gruppo sarà accostato negli anni, probabilmente per la semplice appartenenza alla Sub Pop), tagliente, sviluppato con riff di chitarra fulminanti (“Debonair”, “Fountain and Fairfax”…) ma con tempi delle composizioni invece mai veloci e dettati dal sound del basso e sempre attenti a accompagnare la potentissima voce di Greg Dulli, che non è bellissima, ma che riesce a essere incredibilmente efficace sia quando deve raccontare delle storie (“Be Sweet”, “What Jail Is Like”…) che quando deve dare sfogo alle sue tensioni (“Gentlemen”…) e che è sempre al centro di ogni composizione.
La stessa descrizione di Greg Dulli potrebbe apparire in qualche maniera scorretta, come se avessi voluto delinearne un ritratto negativo e probabilmente lui non ha mai voluto presentarsi in una maniera differente. Continua ancora oggi ha mostrare una certa aggressività, che poi è sempre stata il suo punto di forza, rafforzando in maniera visiva il contenuto delle sue canzoni. Se fa finta, ci riesce sicuramente molto bene. Se dico che mi ricorda Johnny Cash, mi viene in mente una frase dal film “Walk The Line”, quando il padre gli dice, “Adesso che sei finito in prigione, potrai smettere di fare finta di averlo già fatto come canti nelle tue canzoni.” Più o meno facciamo che per Greg Dulli valga lo stesso: in prigione non ci è mai finito veramente, ma se quella voce continua a circolare ancora oggi, evidentemente dà l’aria di essere un vero e proprio duro. E questo funziona o almeno ha funzionato benissimo in quegli anni. Oggi chi lo sa.
#2. ERIC’S TRIP, “Love Tara” (1993)
 Ancora oggi c’è chi ritiene che gli Eric’s Trip di Rick White siano stati il più grande gruppo canadese della storia o comunque uno dei più grandi provenienti dal grande paese nord-americano. Sicuramente nonostante la poca fama “postuma”, le intuizioni di Rick White e del gruppo furono in qualche maniera in anticipo sui tempi e riprendendo l’attitudine Sonic Youth (lo stesso nome del gruppo è ispirato alla band di NYC), il noise-pop Dinosaur Jr e mescolando questa a una forma di cantautorato folk sensibile, spianerà praticamente la strada a esperienze come Sparklehorse oppure tutto quello che poi uscirà su Elephant Six negli anni successivi a partire da Neutral Milk Hotel.
Ancora oggi c’è chi ritiene che gli Eric’s Trip di Rick White siano stati il più grande gruppo canadese della storia o comunque uno dei più grandi provenienti dal grande paese nord-americano. Sicuramente nonostante la poca fama “postuma”, le intuizioni di Rick White e del gruppo furono in qualche maniera in anticipo sui tempi e riprendendo l’attitudine Sonic Youth (lo stesso nome del gruppo è ispirato alla band di NYC), il noise-pop Dinosaur Jr e mescolando questa a una forma di cantautorato folk sensibile, spianerà praticamente la strada a esperienze come Sparklehorse oppure tutto quello che poi uscirà su Elephant Six negli anni successivi a partire da Neutral Milk Hotel.
Parliamo quindi di un grosso pezzo della storia della musica americana indie di quell’intero decennio e di influenze che sono rimaste valide ancora oggi. Sicuramente c’è una ragione se la Sub Pop ha voluto ristampare “Love Tara” (1993), il primo LP della band e prodotto anche qui dal mitico Bob Weston. Il disco fu in realtà uno dei lavori più sorprendenti dell’anno, perché era in qualche maniera completamente imprevedibile e perché pure se usciva fuori da determinati “schemi” ripetuti in maniera forse eccessiva, aveva il coraggio di mostrare il fianco al pubblico scoprendo una sensibilità cantautorale che ricorda la scrittura di Elliott Smith e espressa in canzoni come “Behind The Garage”, gli scorci minimal di “June”, “May 11” e “Allergic to Love”; “Anytime You Want”, “Spring” sono già Neutral Milk Hotel, mentre “Blinded” paga il pegno a Sonic Youth e il resto del disco in buona sostanza riprende il noise-pop dei Dinosaur Jr. Restano “Stove” e “To Know Them”, con uno stile sgangherato tra Daniel Johnston e Sparklehorse e che non tradiscono lo stile e l’attitudine marcatamente lo-fi del gruppo.
Ancora oggi, sebbene tipicamente nineties, “Love Tara” suona come un disco alieno e imprevedibile. Nonostante la ristampa in tempi recenti, è comunque rimasto in qualche maniera poco considerato: è il momento di riscoprirlo e di dare a questa esperienza nel rock canadese i giusti meriti.
#3. VELOCITY GIRL, “Copacetic” (1993)
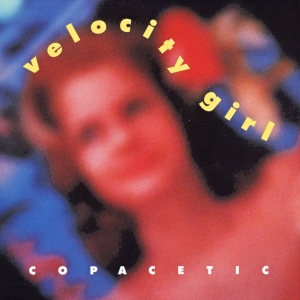 Il periodo che va dalla fine degli anni ottanta all’inizio degli anni novanta è stato chiaramente anche l’epoca d’oro del genere shoegaze. Sviluppatosi forse maggiormente nel Regno Unito, il genere trovò comunque un certo riscontro negli USA già in quel periodo e la Sub Pop Records non si fece sicuramente cogliere alla sprovvista mettendo sotto contratto i Velocity Girl, gruppo fondato nel 1989 e che avrà una carriera breve (così come breve fu l’epopea degli anni d’oro del genere shoegaze) con tre pubblicazioni tutte su Sub Pop Records.
Il periodo che va dalla fine degli anni ottanta all’inizio degli anni novanta è stato chiaramente anche l’epoca d’oro del genere shoegaze. Sviluppatosi forse maggiormente nel Regno Unito, il genere trovò comunque un certo riscontro negli USA già in quel periodo e la Sub Pop Records non si fece sicuramente cogliere alla sprovvista mettendo sotto contratto i Velocity Girl, gruppo fondato nel 1989 e che avrà una carriera breve (così come breve fu l’epopea degli anni d’oro del genere shoegaze) con tre pubblicazioni tutte su Sub Pop Records.
Formatosi a Silver Spring nel Maryland il gruppo contava su Archie Moore alla chitarra, Kelly Ryles al basso e Brian Nelson alla chitarra. Alla voce c’era Bridget Cross ma già prima della pubblicazione del primo LP, la vocalist fu sostituita da Sarah Shannon, il cui timbro vocale e il carattere delle interpretrazioni tipicamente “nineties” marcheranno in maniera indelebile le registrazioni del gruppo.
Il primo LP si intitola “Copacetic” (1993) e si può considerare sicuramente come il manifesto del gruppo (del resto va detto che i successivi “Simpatico!” e “Gilded Stars And Zealous Hearts” riprenderanno in buona sostanza le stesse formule). Registrato con la produzione di un big come Bob Weston, il gruppo propone una specie di shoegaze a bassa intensità (se paragonato ad esempio al suono più massivo My Bloody Valentine) e con venature indie-pop e derivazioni dal rock alternative R.E.M. e canzoni costruite in buona sostanza su ballads di pop elettrico arpeggiate e divagazioni di carattere noise, ma in via generale sempre rispettando la forma canzone e tutto sempre rigorosamente in lo-fi.
Il gruppo non raggiunse mai il meritato successo e che forse avrebbe meritato, forse perché non rientrava effettivamente nei canoni di quello che il pubblico (i cui gusti sono mutevoli) voleva in quel momento specifico, ma quello che si può dire è che pure suonando in una maniera tipicamente nineties, il disco sopravvive al passare del tempo e ancora oggi suona in una maniera che gli appassionati al sound tipico del genere shoegaze non potranno che apprezzare. Anche causa le richiamate anticipazioni dream-pop che si sono sviluppate negli ultimi anni.
#4. CODEINE, “The White Birch” (Sub Pop Records, 1994)
 Quando i ragazzi della redazione hanno proposto di scrivere del trentennale della Sub Pop Records, non ho avuto dubbi: il periodo più importante nella storia della label è stato quello iniziale. Quello che poi ne ha determinato il successo e la ha fatta entrare nella storia. Il periodo iniziale degli anni novanta è stato poi effettivamente ha più condizionato i miei ascolti da ragazzo. Mentirei tuttavia nel dire che la maggior parte di quegli ascolti siano durati nel tempo e fino ad oggi. Però ci sono alcuni dischi e alcuni gruppi che estano nel tempo e tra questi qui per me ci sono sicuramente i Codeine.
Quando i ragazzi della redazione hanno proposto di scrivere del trentennale della Sub Pop Records, non ho avuto dubbi: il periodo più importante nella storia della label è stato quello iniziale. Quello che poi ne ha determinato il successo e la ha fatta entrare nella storia. Il periodo iniziale degli anni novanta è stato poi effettivamente ha più condizionato i miei ascolti da ragazzo. Mentirei tuttavia nel dire che la maggior parte di quegli ascolti siano durati nel tempo e fino ad oggi. Però ci sono alcuni dischi e alcuni gruppi che estano nel tempo e tra questi qui per me ci sono sicuramente i Codeine.
Il trio composto da Stephen Immerwahr (voce, basso), John Engle (chitarra) e Chris Brokaw, musicista fondamentale e tra le altre cose costante collaboratore di Thalia Zedek sin a partire dai Come, si forma a New York City nel 1989 e riesce a pubblicare due dischi, “Frigid Stars LP” e questo “The White Birch”, che ancora oggi sorprendono all’ascolto per la loro bellezza.
Chris Brokaw molla il gruppo definitivamente per i Come (ma ci sarà nella fugace reunion nel decennio scorso) e viene sostituito da Doug Scharin (Rex, HiM, June of 44) e in aggiunta il gruppo viene sostenuto dall’apporto in due tracce (“Tom” e “Wird”) di un musicista incredibilmente talentuoso come David Grubbs.
Si è lungamente discusso sulla definizione di slowcore (che accomuna i Codeine a gruppi come Low, Idaho, Red House Painters) e sul valore effettivo del genere e quanto questo abbia avuto a che fare poi con lo sviluppo massivo di quello che viene definito come post-rock. Io penso che l’unico parallelo possa esservi al limite sul piano emotivo, ma le forme di espressione e cantautorato dei Codene sono di un livello superiore. Le distorsioni nelle canzoni hanno la funzione di letteralmente trascinare il suono e infine dare un maggiore peso al suono delle parole e i testi; va da sé che i pezzi caratterizzati da un maggior uso delle distorsioni (“Sea”, “Loss Leader”, “Kitchen Light”…) siano forse quelle più tipiche della band, ma non mancano momenti di grande profondità ad esempio “Smoking Room”, dove la composizione è già Jackie-o Motherfucker.
Ispirazione anche di una certa sensibilità poi ripresa in ambito propriamente pop anche da gruppi insospettabili tipo i Blur, i Codeine furono una esperienza breve quanto fruttuosa e questo forse ha anche contribuito ad accrescere (giustamente) il mito.
#5. MARK LANEGAN, “Whiskey For The Holy Ghost” (1994)
 Mark Lanegan. Pochi cantautori sono stati osannati quanto lui nel mondo alternative nel ventennio tra gli anni novanta e lo scorso decennio. Una gloria tutta meritata perché bisogna dire che già mentre la storia degli Screaming Trees (che gruppo fantastico) si avviava verso la fine, Mark cominciava a scrivere e pubblicare dischi di una bellezza meravigliosa. Difficile dire quale sia stato il momento più alto tra tutti quelli pubblicati a partire dal meno conosciuto “The Winding Sheet” (divenuto poi oggetto di culto per la presenza di Kurt Cobain in “Wild Flowers” e la solita “Where Did You Sleep Last Night”) e per quanto mi riguarda fino al colossale “Bubblegum” nel 2004, dopo il quale la sua ispirazione ha cominciato a avere un calo. Oppure semplicemente (una spiegazione che mi appare più convincente) è diminuito quell’entusiasmo che lo ha portato comunque per almeno venti-venticinque anni ad essere uno dei più grandi rocker in circolazione.
Mark Lanegan. Pochi cantautori sono stati osannati quanto lui nel mondo alternative nel ventennio tra gli anni novanta e lo scorso decennio. Una gloria tutta meritata perché bisogna dire che già mentre la storia degli Screaming Trees (che gruppo fantastico) si avviava verso la fine, Mark cominciava a scrivere e pubblicare dischi di una bellezza meravigliosa. Difficile dire quale sia stato il momento più alto tra tutti quelli pubblicati a partire dal meno conosciuto “The Winding Sheet” (divenuto poi oggetto di culto per la presenza di Kurt Cobain in “Wild Flowers” e la solita “Where Did You Sleep Last Night”) e per quanto mi riguarda fino al colossale “Bubblegum” nel 2004, dopo il quale la sua ispirazione ha cominciato a avere un calo. Oppure semplicemente (una spiegazione che mi appare più convincente) è diminuito quell’entusiasmo che lo ha portato comunque per almeno venti-venticinque anni ad essere uno dei più grandi rocker in circolazione.
Abbiamo “The Winding Sheet”, “Whiskey For The Holy Ghost”, “Scraps At Midnight”, “I’ll Take Care Of You”, “Field Songs”, “Bubblegum”. Metteteli pure in ordine come vi pare e il risultato non cambia: siamo in tutti i casi davanti a dei dischi di qualità assoluta e che peraltro pure avendo lo stesso protagonista, hanno ciascuno una propria sfumatura particolare e degli accenti diversi. In questo caso specifico (“Whiskey For The Holy Ghost”, 1994) parliamo di quello che in un certo senso dopo il tentativo esplorativo nel 1990 con “The Winding Sheet”, ha dato il via definitivo alla sua carriera solista. Prodotto assieme al suo sempiterno collaboratore Mike Johnson, un musicista che ha avuto un ruolo determinante nella carriera solista di Lanegan, e registrato con la supervisione di due giganti come John Agnello e Jack Endino, il disco vanta tutta una serie di collaborazioni eccellenti, dal solito Mark Pickerel a J Mascis (che qui suona la batteria in “The River Rise” e “Sunrire”) e al contributo centrale di Dave Kreuger al violino in “House A Home” e Justin Williams alle tastiere in “Kingdoms Of Rain”, Frank Cody in “Dead On You”, Mike Stinette (un altro habituè) al sassofono. Il songwriting è assolutamente ispirato e gli arrangiamenti minimali, con un dosato utilizzo della strumentazione elettrica e sempre centrati e focalizzati a rinnovare il mito del blues americano in una atmosfera rituale oscura come i toni del già richiamato Nick Cave, ma se l’australiano appare più come una specie di poeta posseduto dal demonio e che prepotentemente domina la scena con la sua presenza spettacolare e la sua voce, le sue liriche al di là di una poetica che possa essere facile, Mark Lanegan è lo spirito e il cuore solitario e sul filo del rasoio, ma pulsante di una nazione, gli Stati Uniti d’America, che forse oggi manca di un cantautore come lui e che sia immediatamente corrispondente alle nuove generazioni. Non significa che oggi non ci siano grandi cantautori negli USA preferisco saltare a pié pari luoghi comuni di questo tipo, ci mancherebbe, ma la grande popolarità ottenuta da Lanegan (grazie anche proprio alla fortunata collaborazione con la Sub Pop Records, ca vans sans dire) ha formato direttamente una intera generazione non solo di musicisti. Dicono abbia brutto carattere. Chi lo sa. Probabilmente ha solo un carattere schivo, ma non si può dire che non sia una persona generosa: la sua anima qui ce la ha messa a disposizione su di un piatto d’argento. O meglio dentro una bottiglia di whiskey. E noi ce la siamo bevuta tutta.
#6. SEBADOH, “Bakesale” (1994)
 Lou Barlow è un’altra delle figure chiave nel mondo del rock alternative degli anni novanta. Quando nel 1989 il suo rapporto storicamente diciamo “elettrico” con J Mascis si compromette in maniera definitiva (almeno fino alla reunion del 2005) Lou comincia a dare vita a tutta una serie progetti paralleli e pubblicazioni come solista e che spaziano all’interno del vasto mondo della cultura lo-fi degli anni novanta, mischiando in buona sostanza l’eredità di autentici geni della storia della musica come Daniel Johnston e Jad Fair con lo stesso sound noise-pop dei Dinosaur Jr. Si possono menzionare i progetti Sentridoh e Folk Implosion (il primo assolutamente sperimentale e privo di ogni possibile definizione di genere), così come pubblicazioni come solista, tutti momenti più o meno riusciti, ma che dimostrano una iper-prolificità di questo musicisti e in particolare negli anni novanta. Ma il cuore della produzione di Barlow al di fuori dei Dinosaur Jr è sicuramente costituito dalle pubblicazioni con i Sebadoh, progetto messo in piedi assieme a Eric Gaffney, ma poi sostanzialmente sempre ruotato attorno alla sua persona. Gaffney lascia la band del resto per la prima volta nel 1993, poco prima dell’inizio delle lavorazioni di “Bakesale”. I Sebadoh erano già oggetto di culto dopo il boom di “Sebadoh III” e forse questo disco è l’unico che gli si avvicini anche come riscontro presso la critica e in particolare il grande pubblico che all’epoca teneva molto in conto tutte le pubblicazioni nel genere alternative-rock (“Sebadoh III” uscì del resto proprio un mese dopo il decesso di Cobain).
Lou Barlow è un’altra delle figure chiave nel mondo del rock alternative degli anni novanta. Quando nel 1989 il suo rapporto storicamente diciamo “elettrico” con J Mascis si compromette in maniera definitiva (almeno fino alla reunion del 2005) Lou comincia a dare vita a tutta una serie progetti paralleli e pubblicazioni come solista e che spaziano all’interno del vasto mondo della cultura lo-fi degli anni novanta, mischiando in buona sostanza l’eredità di autentici geni della storia della musica come Daniel Johnston e Jad Fair con lo stesso sound noise-pop dei Dinosaur Jr. Si possono menzionare i progetti Sentridoh e Folk Implosion (il primo assolutamente sperimentale e privo di ogni possibile definizione di genere), così come pubblicazioni come solista, tutti momenti più o meno riusciti, ma che dimostrano una iper-prolificità di questo musicisti e in particolare negli anni novanta. Ma il cuore della produzione di Barlow al di fuori dei Dinosaur Jr è sicuramente costituito dalle pubblicazioni con i Sebadoh, progetto messo in piedi assieme a Eric Gaffney, ma poi sostanzialmente sempre ruotato attorno alla sua persona. Gaffney lascia la band del resto per la prima volta nel 1993, poco prima dell’inizio delle lavorazioni di “Bakesale”. I Sebadoh erano già oggetto di culto dopo il boom di “Sebadoh III” e forse questo disco è l’unico che gli si avvicini anche come riscontro presso la critica e in particolare il grande pubblico che all’epoca teneva molto in conto tutte le pubblicazioni nel genere alternative-rock (“Sebadoh III” uscì del resto proprio un mese dopo il decesso di Cobain).
La iper-produttività di Barlow in quegli anni è stata spesso spiegata come lo sfogo e l’esplosione di una personalità per anni soppressa, anche all’interno dei Dinosaur Jr dalla personalità ingombrante di J Mascis. Probabilmente la cosa è stata poi negli anni anche amplificata nei media, ma va detto che fino a questo punto Barlow non sbaglia un colpo. Anzi in questo caso specifico Barlow, liberatosi pure di Gaffney, raggiunge il culmine sul piano compositivo con un disco che forse è ripetitivo, ma che suona come un vero e proprio manifesto del rock di quegli anni. Le canzoni sono tutte di breve durata, riprendendo uno stile caro a Minutemen oppure il super-prolifico Robert Pollard, il sound assolutamente piacevole sia nei pezzi più tipicamente pop che quando si spinge più forte sull’acceleratore e sonorità noise.
Diciamo che questo qui è il tipico disco in cui si compie quel miracolo della affermazione della semplicità e dell’istinto, due caratteristiche che sono difficili da mantenere nel tempo, riuscendo a ottenere sempre buoni risultati e un grande riscontro. Qui tutto questo riesce, perché Barlow era molto ispirato, perché in quel periodo questo era quello che i ragazzi volevano sentire: il disco giusto al momento giusto.
#7. FRIENDS OF DEAN MARTINEZ, “The Shadow Of Your Smile” (1995)
 I Calexico prima dei Calexico. Siamo ovviamente a Tucson in Arizona ed è il 1995. Joey Burns e John Convertino (ancora membri in pianta stabile dei Giant Sand di Howe Gelb) daranno il via al progetto Calexico solo l’anno dopo, quando viene pubblicato il primo disco dei Friends of Dean Martinez, un combo di cinque elementi completato da Bill Elm alla steel guitar e Van Christian Tommy Larkins dei Naked Prey. John Convertino, che considero un musicista semplicemente fantastico, qui suona pure il vibrafono e ovviamente tra le tante guest di questo primo disco intitolato “The Shadow Of Your Smile”, trova spazio anche lo stesso Howe Gelb che scrive di suo pugno la ballata per piano “Blood Of The Earth” e dà peraltro prova delle sue doti istrioniche come musicista e “gigione”.
I Calexico prima dei Calexico. Siamo ovviamente a Tucson in Arizona ed è il 1995. Joey Burns e John Convertino (ancora membri in pianta stabile dei Giant Sand di Howe Gelb) daranno il via al progetto Calexico solo l’anno dopo, quando viene pubblicato il primo disco dei Friends of Dean Martinez, un combo di cinque elementi completato da Bill Elm alla steel guitar e Van Christian Tommy Larkins dei Naked Prey. John Convertino, che considero un musicista semplicemente fantastico, qui suona pure il vibrafono e ovviamente tra le tante guest di questo primo disco intitolato “The Shadow Of Your Smile”, trova spazio anche lo stesso Howe Gelb che scrive di suo pugno la ballata per piano “Blood Of The Earth” e dà peraltro prova delle sue doti istrioniche come musicista e “gigione”.
Il concept è molto semplice: un collettivo di musicisti che si riuniscono per mettere in piedi quella che è una specie di polverosa orchestra del deserto tra celebrazioni del caro vecchio far west e ripresa di colonne sonore morriconiane e vecchi standard country-western (“All The Pretty Horses”) e americana. Ma dentro ci sono anche “I Wish You Love” di Charles Trenet, “Misty” di Erroll Garner, “Ugly Betty” di Thelonious Mok e “The Shadow Of Your Smile” di Johnny Mandel e tutto questo senza considerare determinate fascinazioni tzigane che fanno pensare a immaginari da film di Emir Kusturica, che peraltro proprio in quegli anni otteneva i suoi massimi riconoscimenti, e ritmi e tempi da orchestrina jazz, quasi da balera, vecchi bolero e malinconici giri di tango.
Qualcuno ha parlato di post-rock, ma c’è stato un momento in cui tutto quello che usciva e che uscisse fuori da determinati canoni più o meno standard veniva definito sempre e comunque come “post-rock”. Adesso che per fortuna siamo usciti da questi schemi, possiamo dire che questa esperienza fu a suo tempo particolare proprio perché originale portata su “grande schermo”, ma in fondo non faceva altro che esprimere quelle che erano e sono attitudini naturali per dei musicisti scafati come pochi e che conoscono questi pattern e tipi di sonorità come il fondo delle loro tasche. L’idea ovviamente era buona, negli anni la hanno ripresa un sacco di gruppi con successi più o meno alterni e qualche cosa di molto bello di questo tipo esce ancora oggi. Un esempio? A febbraio i Richmond Fontaine, dopo avere annunciato già l’anno scorso la fine di questa altra meravigliosa esperienza nel panorama della musica americana, hanno pubblicato “Don’t Skip Out On Me”, la colonna sonora ideale dell’ultimo romanzo di Willy Vlautin. Un lavoro semplicemente delizioso. Colonne sonore. Musiche che raccontano delle storie senza tempo e senza bisogno di parole.
(Emiliano D’Aniello)








