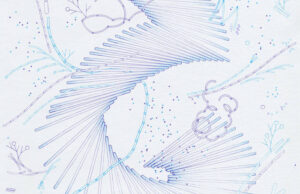TV ON THE RADIO, Dear Science (4AD, 2008)
 C’era chi si aspettava il capolavoro. “Dear Science” non lo è e questa, per il sottoscritto, è una cattiva notizia.
C’era chi si aspettava il capolavoro. “Dear Science” non lo è e questa, per il sottoscritto, è una cattiva notizia.
Grandissima l’attesa, “Golden Age” e “Dancing Choose”, diffuse sul sito ufficiale, soffiavano come mantici sulle fiamme di una certa urgenza dance e noi lì, dita intrecciate davanti allo schermo del pc, a chiederci se il nostro guardaroba sarebbe stato all’altezza di una serata passata in discoteca a ballarle.
Ma eccoci col disco tra le mani. “Halfway Home” inaugura nel migliore dei modi, notturna come le luci del cruscotto mentre attraversate la città coi riflessi gialli e sghembi dei lampioni sul cristallo, dichiarazione d’intenti tesa e onirica, battiti di mani che appuntano il tessuto dei sintetizzatori e dei falsetti cangianti. E subito dopo il tappeto ritmico esemplare e il calore nelle vene e nelle lacrime di “Crying”, ecco “Dancing Choose” che prende il controllo della situazione sulla scia di una festa rap incalzante.
Tutto bene sin qui. Qualche dubbio affiora con “Stork & Owl”, così formalmente perfetta da destare il sospetto che di sostanza ce ne sia poca. La fiducia torna con “Golden Age” e la sua sessualità esibita tra Prince e Michael Jackson, ritornello ecumenico ed una strana commistione di dance e orchestra che ad un certo punto lascia quasi affiorare un’inconscia citazione dei Kraftwerk.
Guai seri arrivano con “Family Tree” e la sua prosopopea che per qualcuno sarà maturità, per me è un segnale di resa incondizionata ad una senilità alquanto precoce. Sullo stile (molto preoccupante la cosa) degli ultimi U2 e Coldplay, il brano riesce a tagliare in due il disco. A proposito, non avevate già notato coi precedenti che intorno alla metà dell’album i TVOTR hanno il vizio di rallentare (ritmo ed emozioni)? Solo che questa volta non c’è qualcosa del calibro di ”Ambulance” ma un’accozzaglia di archi celestiali e melodie buoniste che attentano alla salute dei diabetici. Peccato, veramente, Lionel Ritchie è decisamente prossimo.
Successivamente “Red Dress” e “Shout Me Out” proveranno a rialzare il tiro, fallendo impantanandosi una in un manierismo afro-beat, l’altra in una ruffianeria elettronica che nasconde forse pochezza di idee sui possibili sviluppi del brano. Per fortuna la delusione viene arginata da “Love Dog”, ballata scura della stessa famiglia di “Family Tree” e “Stork & Owl”, ma con ben altro cuore pulsante. E poi, prima dell’epilogo, “DLZ” recupera un po’ della tensione persa nei primi due dischi. È “Lover’s Day” a chiudere i conti, con la serenità di una domenica mattina coi postumi di una sbronza.
Abbiamo fatto le pulci all’album, ma, a parte le cadute di stile, qual è il vero problema? Siamo alle prese con un ottimo disco, un disco importante e formalmente inappuntabile. Eppure ho l’impressione che, in buona parte, manchi qualcosa. Quello che aveva reso magnifiche le prime due prove. Il sudore. La preoccupazione. L’attesa. Il vuoto. Il rumore. La confusione. Il gioco. Il disorientamento. La sfrontatezza. L’ardore. L’erezione. La cupezza sotto pelle. Le carezze e le lacrime. La mancanza di equilibrio. Le labbra strette tra i denti. Quello strano ribollire nello stomaco quando guardi negli occhi l’oggetto del desiderio.