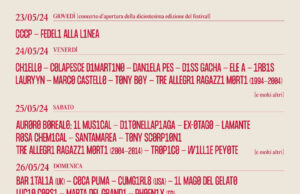PHOENIX, United (Astralwerks, 2000)
 Phoenix, ovvero la grande mistificazione. Ascoltando il loro disco, “United”, la memoria affonda nel suono dell’America di fine anni ’70, in cui il rock si bagnava di spruzzi jazz e soul, alternandosi a sfumature country. E qui sta l’inganno: non solo i Phoenix non provengono dagli anni ’70, ma non vengono nemmeno dall’America, bensì dalla Francia, Paese che con il rock non è mai stato molto amico.
Phoenix, ovvero la grande mistificazione. Ascoltando il loro disco, “United”, la memoria affonda nel suono dell’America di fine anni ’70, in cui il rock si bagnava di spruzzi jazz e soul, alternandosi a sfumature country. E qui sta l’inganno: non solo i Phoenix non provengono dagli anni ’70, ma non vengono nemmeno dall’America, bensì dalla Francia, Paese che con il rock non è mai stato molto amico.
Una volta superato il piacevole stupore, ci si può abbandonare alle note di questo album assolutamente delizioso e godibilissimo già dal primo ascolto. Ogni brano ha un gusto e un colore assolutamente originale e perfettamente riconoscibile.
Dopo l’intro strumentale, si parte con uno dei singoli tratti dal disco, “Too Young”, brano dall’impatto sicuro, grazie alla sua semplice struttura e al suo ritmo trascinante, sostenuto da quel suono di synth “d’annata” che scandisce il pezzo. I riferimenti più vicini sono proprio i gruppi pop-jazz-rock americani di fine anni ’70 primi anni ’80, come Steely Dan, Supertramp e simili, la cui immediatezza e orecchiabilità dei brani andava d’accordo con un’estrema cura per i suoni e gli arrangiamenti.
E la musica va avanti, con brani preziosi e dalla bellezza indiscutibile; “Honeymoon”, dolce ballata dal sapore country, con un arpeggio, nel ritornello, in grado di strappare le lacrime anche ai fans più esigenti dei Genesis; “If I Ever Feel Better”, grandioso funky-dance trascinatore di folle, con quella chitarra dalla grana sottile appena percettibile e la batteria secca come non mai, come la disco music comandava, a sostenere “quel ritmo incalzante di cassa e rullante” a cui è impossibile resistere.
Ma pare che i Phoenix non si accontentino di sembrare una revival band; oltre ad altri brani meravigliosi come “On Fire”, bellissima canzone rock-soul che sembra partorita da Stevie Wonder, con quel suono di clavinet che fa tanto anni ’70, o come “Embuscade”, raffinato brano pop-jazz strumentale, i quattro francesi provano altre strade, come l’incursione nel punk con “Party Time”, a dire il vero episodio tra i meno felici nel disco, o la giustapposizione di più stili come in “Funky Squaredance”, grandiosa suite della durata di dieci minuti, in cui si passa dallo “slow tempo” country a cui già ci avevano abituato, a stacchi techno dance, per poi chiudere con un’esplosione heavy metal in cui il chitarrista dà libero sfogo alla sua vena “vanhaleniana”.
Niente da dire; un disco ineccepibile, come pochi ancora ne escono, e un gruppo che gioca con la tradizione per farla propria e per restituire qualcosa di assolutamente interessante e maledettamente piacevole.