PIXIES, “Indie Cindy” (PixiesMusic/PIAS 2014)
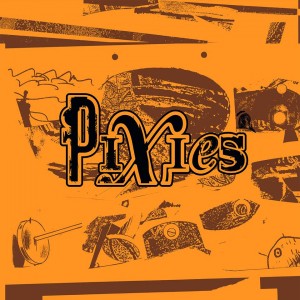 Gran parte di ciò che accadde all’alternative rock degli anni Novanta fu la logica conseguenza di ciò che i Pixies realizzarono sul finire degli Ottanta. Segnarono un’epoca e una direzione nuova, proponendo uno schema semplice e azzecatissimo, che risultava essere molto più che una somma di parti: gli ingredienti erano la melodia, cui non seppero e non vollero mai rinunciare; la distorsione feroce; le liriche oscure, scomode e dense di riferimenti; tutti insieme componevano un quadro di lucida schizofrenia, una formula magica. Formula che perse di efficacia nel giro di un buon EP e due grandi album – “Come On Pilgrim”, (1987) “Surfer Rosa” (1988), “Doolittle” (1989), tutti per l’etichetta 4AD – in cui vennero sfruttate e portate a compimento tutte le poche, ma chiare e distinte idee di cui il duo Francis/Deal fu in grado. Logica conseguenza del modus operandi messo in pratica furono anche i due mediocri album successivi. Si era già saturato quel linguaggio volutamente povero che i Pixies avevano inventato e adoperato con tanta facilità e naturalezza. Le stesse idee, che ormai erano copie sbiadite, venivano replicate e portate alla parodia di sé stesse, e i Pixies sembravano aver detto tutto ciò che avevano da dire. Una carriera breve e gloriosa, seguita da un silenzio durato più di vent’anni e interrotto di quando in quando da un tour o dall’uscita di una compilation.
Gran parte di ciò che accadde all’alternative rock degli anni Novanta fu la logica conseguenza di ciò che i Pixies realizzarono sul finire degli Ottanta. Segnarono un’epoca e una direzione nuova, proponendo uno schema semplice e azzecatissimo, che risultava essere molto più che una somma di parti: gli ingredienti erano la melodia, cui non seppero e non vollero mai rinunciare; la distorsione feroce; le liriche oscure, scomode e dense di riferimenti; tutti insieme componevano un quadro di lucida schizofrenia, una formula magica. Formula che perse di efficacia nel giro di un buon EP e due grandi album – “Come On Pilgrim”, (1987) “Surfer Rosa” (1988), “Doolittle” (1989), tutti per l’etichetta 4AD – in cui vennero sfruttate e portate a compimento tutte le poche, ma chiare e distinte idee di cui il duo Francis/Deal fu in grado. Logica conseguenza del modus operandi messo in pratica furono anche i due mediocri album successivi. Si era già saturato quel linguaggio volutamente povero che i Pixies avevano inventato e adoperato con tanta facilità e naturalezza. Le stesse idee, che ormai erano copie sbiadite, venivano replicate e portate alla parodia di sé stesse, e i Pixies sembravano aver detto tutto ciò che avevano da dire. Una carriera breve e gloriosa, seguita da un silenzio durato più di vent’anni e interrotto di quando in quando da un tour o dall’uscita di una compilation.
Poi, l’anno scorso, la notizia che Kim Deal, bassista, cantante e seconda mente del gruppo, abbandona la band (quando non si era nemmeno più tanto sicuri ci fosse una band da abbandonare); due settimane dopo, l’uscita di un brano inedito in free download, “Bagboy”, anthem senza mordente che pare uno scarto di quell’ultimo bruttino “Trompe Le Monde”; a partire dal settembre dello stesso anno, con cadenza trimestrale, tre EP, per un totale di dodici brani (“Bagboy” inclusa), tutti davvero insignificanti e deludenti (in prima linea quella che sarà la title track dell’album); brani infine raccolti nell’album uscito questo aprile, “Indie Cindy”. Riassumendo: una pausa di ventidue anni, l’abbandono di un membro fondamentale, tre EP scadenti, un album contenente il tutto, in cui la vecchia formazione (monca di Kim Deal) è affiancata da Simon Archer, Paz Lenchantin e Jeremy Dubs che pensano ai bassi e alle controvoci. Nessun episodio degno di nota in mezzo a dodici.
La domanda è tremendamente semplice: ce n’era bisogno? La risposta lo è altrettanto: decisamente no. Un lavoro che se non portasse la firma di Black Francis ci si potrebbe limitare a definire “superfluo”, o “datato”, ma che in questo caso appare semplicemente ridicolo. Francis sembra prendersi gioco dei fan di vecchia data, riproponendo vecchi stilemi arrugginiti accompagnati da una rabbia addomesticata che non ha niente di autentico; e, al contempo, sembra non curarsi affatto di tutto un pubblico che gli anni Novanta non li ha mai vissuti, i nuovi ascoltatori per i quali non si può contare unicamente sull’affetto. In mezzo a tutto questo, ci sono canzoni semplicemente molto brutte (“Andro Queen”).
In casi come questi la speranza è sempre quella che una grande band del passato riesca a riproporre la sua identità espressiva, sfruttando l’esperienza e integrando questa con nuove forme di comunicazione. Ma questa speranza non è quasi mai soddisfatta, e di solito tocca rassegnarsi all’idea che ai grandi del passato piacciono un sacco soldi e autocelebrazione. Perché sì, avevano già detto tutto nel 1989.
45/100
(Pietro Di Maggio)
20 maggio 2014








