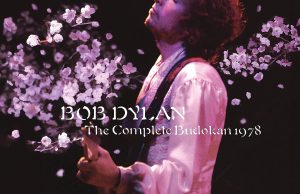BOB DYLAN, Blood On The Tracks (Columbia, 1975)
 Da un precursore come è stato Bob Dylan è facile aspettarsi sempre e comunque di tutto.Anche che a metà anni ’70 pubblichi un lavoro che potrebbe essere benissimo di dieci anni prima. Sì perché “Blood On The Tracks” odora di folk cantautorale come poco materiale del menestrello.
Da un precursore come è stato Bob Dylan è facile aspettarsi sempre e comunque di tutto.Anche che a metà anni ’70 pubblichi un lavoro che potrebbe essere benissimo di dieci anni prima. Sì perché “Blood On The Tracks” odora di folk cantautorale come poco materiale del menestrello.
E’ essenzialmente il disco più acustico mai fatto da Dylan, ma ciononostante non è un passo indietro nella produzione artistica di Mr. Robert Allen Zimmerman. E’ un album costruito interamente sul tema della delusione amorosa, e la sua esecuzione (quasi totalmente chitarra e voce) può, ad un primo ascolto, far pensare ad un lavoro amatoriale. Ed è questo l’esito al quale vuole pervenire Dylan, per il quale le origini (della musica in generale non solo della sua) sono sempre state punto di riferimento perenne, mai rinnegate dalle svolte rock.
Dylan, reduce da lavori male accolti dalla critica a cavallo tra anni ’60 e ’70, quando per alcuni era già artisticamente vecchio, ci fa riassaporare in queste ottime dieci tracce, il suo lato migliore di folk-singer sentimentale. Il titolo stesso (“Blood On The Tracks”) è significativo della passione che travolse l’autore nella composizione di questo lavoro indubbiamente molto ispirato.
I successi non mancano a partire dall’ iniziale “Tangled Up In Blue”, ritmica composizione folk-blues, che ci racconta il flashback di un incontro problematico fra un uomo ed una donna. L’uomo, povero (in tutti sensi) e disperato (personaggio tipico in molti brani anche precedenti di Dylan) e la donna, solitamente diversa da come appare ad un primo incontro, sono un po’ il filo conduttore dell’intero lavoro.
Nel secondo pezzo, “Simple Twist Of Fate”, forse uno dei migliori brani fingerpicking di Dylan, si cerca di rendere più comprensibili le delusioni (in particolare amorose) e di prendere la vita come viene, tanto ciò che succede è solo un banale “attorcigliarsi” del destino.
Dedica alla figura femminile anche nel terzo brano “You’re A Big Girl Now” (il cui inizio mi ricorda ogni volta “Giorno di pioggia” di Francesco De Gregori, peraltro precedente) nel quale si arriva alla conclusione che le stranezze della donna sono motivate semplicemente dal fatto che lei non è altro che una ragazza cresciuta.
Dylan in questo disco è un uomo maturo, che riesce più lucidamente a capire l’altro sesso e non come nei dischi della gioventù dove sarcasmo e ironia sull’argomento abbondano. Qui la riflessione è più seria ma mai comunque banale e scontata, come anche nella quasi-arrabbiata cantata di “Idiot wind”.
Il folk esasperato di “You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go” che può sembrare un ritorno alle ironie giovanili, è invece una serena constatazione di come un uomo rimane dopo l’abbandono da parte della sua amata. La maniera distaccata del canto di Dylan può far sì che le canzoni non siano sentite dall’artista, pur essendo invece tutte autobiografiche.
Non può mancare il più classico dei blues della desolazione che qui è “Meet Me In The Morning”. Nel successivo brano, “Lily, Rosemary and the Jack of The Tearts”, che pecca di eccessiva lungaggine, l’atmosfera è western e l’armonica iniziale è suonata in maniera molto innovativa, quasi distorta. Il ritmo complessivo è decisamente trascinante ma come già detto, è forse eccessiva la durata del pezzo.
Le ultime tre canzoni sono forse le migliori di un album che ha decisamente pochi colpi bassi. La prima del trittico conclusivo,”If You See Her Say Hello” è probabilmente la più bella canzone d’amore scritta da Dylan (commovente l’arpeggio iniziale di circa quaranta secondi). Il brano è un indiretto colloquio con l’amata, tramite una persona terza. Dylan vuole negare il suo stato d’animo da uomo deluso di fronte alla donna che l’ha lasciato, pur provando una disperata nostalgia per lei. Bellissima la versione italiana di Franceso De Gregori (vero e proprio discepolo di Dylan) che si intitola “Non dirle che non è così” (che poi oltre ad essere un verso tradotto della canzone originale, è anche il significato della stessa).
Altro cult è la celeberrima “Shelter From The Storm”, bellissimo racconto dell’incontro con l’amata che gli offre apparentemente la serenità e la felicità. Si chiude con “Buckets Of Rain” in cui la metafora della pioggia dovrebbe rappresentare le lacrime versate per colpa dell’amore. La pioggia come le lacrime lavano il vecchio e lasciano posto al nuovo: bisogna quindi lasciare il passato alle spalle. La conclusione è perfetta con questo brano che testimonia la logica fine di un amore che non può mai comunque prescindere l’incerdere della vita.
Dylan, se mai con questo album abbia voluto azzerarsi, ci è riuscitio come meglio non poteva. Essere capace di tornare alle origini, pur con la consapevolezza di avere dieci anni di più, è il pregio che ha l’autore nello stendere questo lavoro. Testimonianza viva di come Dylan sappia ogni volta partire da zero, nella discografia del menestrello questo disco è seriamente candidato al posto di capolavoro assoluto.