LANA DEL REY, “Born To Die” (Interscope, 2012)
 Elizabeth Grant ha un anno meno di chi scrive e, del tutto realisticamente, potrebbe molto presto tenere il mondo intero in suo pugno. Per farlo si è scelta un nome un po’ patinato da pornodiva romantica, Lana Del Rey, il che la rende forse più vicina, afferrabile agli occhi di un pubblico ex-adolescente. Esordiente nel 2010 con l’album (inizialmente solo digitale) “Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant”, che pochi all’epoca notarono, torna ora in pompa magna con un lavoro nuovo di zecca, “Born To Die”, chiacchieratissimo e sulla bocca di tutti da mesi. A guardarsi un po’ intorno e saggiando le prime reazioni critiche al fenomeno, pare proprio che, dopo un periodo piuttosto lungo di culto internautico serpeggiante, la nuova moda imponga di sbeffeggiare a cuor leggero la ragazza, stroncandone le ambizioni artistiche con malcelato umorismo.
Elizabeth Grant ha un anno meno di chi scrive e, del tutto realisticamente, potrebbe molto presto tenere il mondo intero in suo pugno. Per farlo si è scelta un nome un po’ patinato da pornodiva romantica, Lana Del Rey, il che la rende forse più vicina, afferrabile agli occhi di un pubblico ex-adolescente. Esordiente nel 2010 con l’album (inizialmente solo digitale) “Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant”, che pochi all’epoca notarono, torna ora in pompa magna con un lavoro nuovo di zecca, “Born To Die”, chiacchieratissimo e sulla bocca di tutti da mesi. A guardarsi un po’ intorno e saggiando le prime reazioni critiche al fenomeno, pare proprio che, dopo un periodo piuttosto lungo di culto internautico serpeggiante, la nuova moda imponga di sbeffeggiare a cuor leggero la ragazza, stroncandone le ambizioni artistiche con malcelato umorismo.
Lei si definisce fantasiosamente “gangsta-Nancy Sinatra” e forse c’è del vero in questo (ossessivo) lavoro di auto-iconizzazione (si ci passate l’infelice neologismo) che caratterizza praticamente ogni suo movimento. Ma cosa vuol dire? Uno mette su canzoni come “Off The Races”, “Radio” o “National Anthem” (raffrontandole con i singoli arcinoti “Blue Jeans” o “Video Games”) e all’istante capisce: da buona americana cosmopolita (l’anagrafe dichiara natali newyorchesi) la Del Rey ha metabolizzato a dovere lampi di hip hop e r’n’b metropolitano (quel beat tremolante e gommoso che da Beyoncè arriva fino a Rihanna). Eppure l’anima più trendy della ragazza sa tingersi spesso e volentieri di un gusto tutto suo, obliquo e oscillante, per la ballata sadcore più ombrosa (da scritta d’addio col rossetto sullo specchio e taglio reciso delle vene), nella quale si ritrovano in filigrana vaghi rimandi a Cat Power, Fiona Apple, forse Hope Sandoval. In questo senso si ascoltino l’eponima “Born To Die”, l’ottima “Million Dollar Man”, “Summertime Sadness” o “Dark Paradise”, nelle quali tuttavia una patina troppo lucida e archi eccessivamente insistiti finiscono col soffocare i dettagli.
A produrre troviamo del resto un manipolo di temibili boss dall’estrazione mista: da Emile Haynie, fiancheggiatore dell’ultimo Kid Cudi, fino a Rick Nowles, che qualcuno ricorderà recentemente al lavoro sul sottovalutato “Wounded Rhymes” di Lykke Li. Di suo la Del Rey ci mette una voce duttile, un po’ languida lolita un po’ bambolina gonfiabile, accompagnando il tutto con vestiti studiatamente hypster e le ormai famose labbra ingigantite con iniezioni generose di silicone. Labbra che conferiscono alla ragazza una bellezza precocemente sfiorita, forzata e come già implosa in una perenne sbavatura, plasticosa ma in modo disperato, desolante. Come dire: una Sylvia Plath con Jay-Z in cuffia. “Born To Die” le somiglia e si lascia ascoltare per quello che è, ovvero un compromesso imperfetto tra mainstream milionario e “angst” indie, spesso smarrendo un senso preciso di appartenenza stilistica, altre volte ritrovando un suo equilibrio e una sua verità, aderente allo spirito dei tempi che andiamo vivendo. Non lascerà ricordi troppo profondi ma, nel frattempo, impregnerà di sé sale d’aspetto, supermercati, bar, semafori rossi in attesa del verde. Le nostre vite.
67/100
(Francesco Giordani)
1 febbraio 2012

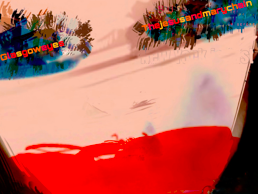







1 Comment