Bob Dylan a 80: intervista con il Prof. Richard F. Thomas, autore di “Why Bob Dylan Matters”
In occasione dell’80º compleanno di Bob Dylan, il Professor Richard F. Thomas, docente di Lettere Classiche ad Harvard, discute con Samuele Conficoni dei suoi saggi sul cantautore Premio Nobel. [Qui la versione in inglese]

Richard F. Thomas è docente di Lettere Classiche presso l’Università di Harvard. È nato a Londra ed è cresciuto in Nuova Zelanda. Dal 2004 tiene un seminario su Bob Dylan per matricole e da anni scrive saggi su di lui. Uno dei suoi primi contributi alla cosiddetta “Dylanologia” è stato il suo saggio del 2007 “The Streets of Rome: The Classical Dylan” (in Oral Tradition 22/1), dove ha rintracciato riferimenti a Virgilio, Ovidio, Tucidide e alla letteratura italiana medievale e rinascimentale all’interno del corpus dylaniano. È autore dell’ottimo Why Bob Dylan Matters (Dey Street Books 2017), uno dei saggi più rilevanti ed esaustivi riguardo all’opera di Dylan. Il libro è stato da poco tradotto in italiano da Elena Cantoni e Paolo Giovinazzi con il titolo Perché Bob Dylan (EDT 2021). Per citare un pensiero appassionato espresso da Italo Calvino, un classico è un’opera – non necessariamente un libro – che “non ha mai finito di dire quel che ha da dire”, del quale diciamo che “’Sto rileggendo…’ e mai ‘Sto leggendo… ‘”.
A fronte di ciò, Bob Dylan è indubbiamente un artista dello stesso calibro di quelli studiati nei tradizionali corsi universitari. La sua influenza su musicisti, poeti, romanzieri e persino cineasti è quasi impossibile da riassumere. Riascoltiamo e riviviamo la sua musica meditando su ogni singolo verso, parola o accento. La sua voce è un sentiero per le Muse che cantano attraverso di lui, proprio come fa intendere nella chiusura della sua Nobel Lecture diffusa nel giugno 2017. Nella medesima Lecture, Dylan parla di alcuni dei libri e degli artisti che più l’hanno ispirato: tra questi c’è l’Odissea, il più antico poema della Grecia Antica insieme all’Iliade. Non fu una sorpresa: Dylan aveva iniziato a citarla sin dal 2012, nel suo ottimo Tempest. In più, dal 2014, in concerto, cantava una versione parzialmente riscritta di “Workingman’s Blues #2”, brano contenuto in Modern Times (2006), le cui profonde modifiche liriche rimandano proprio ai poemi omerici e rendono la canzone la sua “personale” Iliade e Odissea e, probabilmente, Eneide, dal momento che sappiamo che apprezza molto e cita spesso anche Virgilio. Dal vivo ha modificato anche non pochi versi di “Long and Wasted Years”, contenuta su Tempest, aggiungendo riferimenti a Omero. Intervistato nel 2016 dal Daily Telegraph, Dylan riconobbe che alcune delle sue canzoni hanno “indubbiamente un valore omerico”.
Benché in Chronicles Vol. 1 (Simon & Schuster 2004, trad. it. di Alessandro Carrera, Feltrinelli 2005) Dylan fornisca dettagli riguardanti il suo iniziale avvicinamento a Tucidide e a Tacito, a Svetonio e a Machiavelli, e nella sua “Tangled Up in Blue” (scritta nel 1974 e pubblicata su Blood on the Tracks, 1975) canti di un non precisato poeta italiano del 13° secolo, riferimenti specifici ad autori greci e latini all’interno della sua opera sono piuttosto recenti. Tuttavia, nota Thomas nel suo libro, la fascinazione di Dylan per Roma risale almeno al 1962, quando – anche se le fonti non sono concordi – fece un viaggio nella capitale italiana e scrisse “Goin’ Back to Rome”. Roma viene citata anche in “When I Paint My Masterpiece”, pubblicata per la prima volta sulla Greatest Hits Vol. 2 (1971). Molti anni dopo, nel 2001, a Roma, in un’intervista rilasciata a Repubblica in occasione di un suo show, pochi mesi prima dell’uscita dell’eccezionale “Love and Theft”, Dylan parlò delle età dell’uomo in termini esiodei, e nel 2015, intervistato da AARP Magazine, disse che, se avesse dovuto rifare tutto da capo, sarebbe diventato un docente di storia romana o di teologia. Proprio quando pensi di aver compreso la sua arte, Dylan è già un passo avanti. Tutto sta in una delle sue massime, “don’t look back”. E si arriva a oggi, giorno in cui compie 80 anni.
Samuele Conficoni ha avuto il piacere di chiacchierare con il Professor Richard F. Thomas del perché Bob Dylan, nelle sue parole, “is part of that classical stream whose spring starts out in Greece and Rome and flows on down through the years, remaining relevant today, and incapable of being contained by time or place”, e del perché “long ago joined the company of those ancient poets”.

Professor Thomas, quale finalità ha il seminario su Bob Dylan che tiene ad Harvard dal 2004 e come mai ha scelto questo particolare approccio per studiare e insegnare l’opera dylaniana?
Le finalità sono evolute mentre l’arte di Bob Dylan continuava a evolvere. Quando iniziai il seminario non erano ancora usciti Modern Times, Together Through Life, Tempest, Rough and Rowdy Ways, perciò il mio scopo di iniziare un gruppo di diciottenni all’intera opera dylaniana è diventato sempre più irraggiungibile. Alcuni dei ragazzi vi prendono parte conoscendo Dylan, una manciata anche molto a fondo. Tuttavia, sin dall’inizio il mio scopo era connesso al desiderio che gli studenti potessero entrare davvero nelle dinamiche delle canzoni di Dylan, capire come queste funzionino all’interno degli album e in ogni loro prospettiva performativa: musicale, letteraria, estetica, culturale, politica. Si potrebbe tenere un seminario su ciascuna di queste tematiche e il mio non può essere onnicomprensivo. Tuttavia, ci concentriamo su periodi particolarmente decisivi nel suo percorso, inclusi gli ultimi decenni. Un seminario per matricole, con studenti che preparano ogni anno un numero limitato di brani e presentano poi le loro ricerche all’intero gruppo, mi è sembrato il modo ideale per far sì che una comunità di giovani potesse aggiungere Dylan al centro del suo canone, e la cosa funziona.
Come presenterebbe il suo cruciale Why Bob Dylan Matters ai lettori italiani che finalmente possono leggerlo in traduzione? Penso che sia uno dei libri più rilevanti mai scritti su Bob Dylan.
Spero che i lettori italiani apprezzeranno il libro. Come Dylan, fui attirato verso Roma e l’Italia antica da ragazzo, in Nuova Zelanda, il posto più lontano in cui puoi trovarti rispetto a Roma, attraverso i film di fine Anni ’50 e inizio anni ’60, qualche anno dopo rispetto a Dylan, anche se molti di quei film sono gli stessi che vide anche lui: The Robe, Ben Hur, Spartacus, Cleopatra. Iniziai a studiare latino circa nello stesso periodo, in parte proprio per via di quei film, senza guardarmi indietro. Far sì che il mio libro fosse tradotto in italiano era una delle mie ambizioni dal momento che è in Italia che è nato gran parte di esso. In Italia c’è grande rispetto per la poesia, la canzone e le tradizioni poetiche, ovviamente grazie a Dante, poeta de l’una Italia, e attraverso di lui si arriva da un lato fino a Virgilio e dall’altro, in avanti, a Petrarca e a tutto ciò che ne seguì. Dylan è conscio di ciò, come ha dichiarato nell’intervista a Roma nel 2001. Dal mio punto di vista questa è la ragione per cui tenne due concerti particolarmente speciali all’Atlantico di Roma il 6 e 7 novembre 2013. Nel libro scrivo di come secondo me stesse “salutando” l’abbondante dozzina di canzoni che non eseguiva da anni e che invece ha cantato in quelle due serate a Roma. Furono un regalo per la città e, a oggi, alcune di esse sono state suonate lì per l’ultima volta.
Roma e l’Italia scorrono nel sangue di Dylan. Le rintracciamo già nella sua giovinezza, quando era un ragazzino, e sono vive e vitali ora che ha compiuto ottant’anni, dal Rubicone a Key West, nell’immaginario delle sue canzoni recenti. Riuscii a essere in Italia tre anni fa, all’inizio di aprile del 2018, dopo che il libro era uscito, e vidi Dylan in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma e nella città natale di Virgilio, Mantova, nei pressi del Mincio, al Palabam, ora Grana Padano Arena. Fu un’esperienza magica: le canzoni di Bob Dylan nella città natale di Virgilio. Nel corso della giornata feci il mio classico pellegrinaggio alla statua medievale di Virgilio in cattedra, che risale al 13° secolo, scolpita sulla facciata del Palazzo del Podestà. Vidi la meravigliosa Camera degli Sposi di Mantegna, Ovidio e i giganti a Palazzo Te e il monumento fascista di Virgilio nella Piazza Virgiliana. Da Virgilio di giorno a Bob Dylan di notte. La scaletta includeva “Early Roman Kings”, che mi riportò al mio pellegrinaggio. Spero che ciò emerga nel libro.
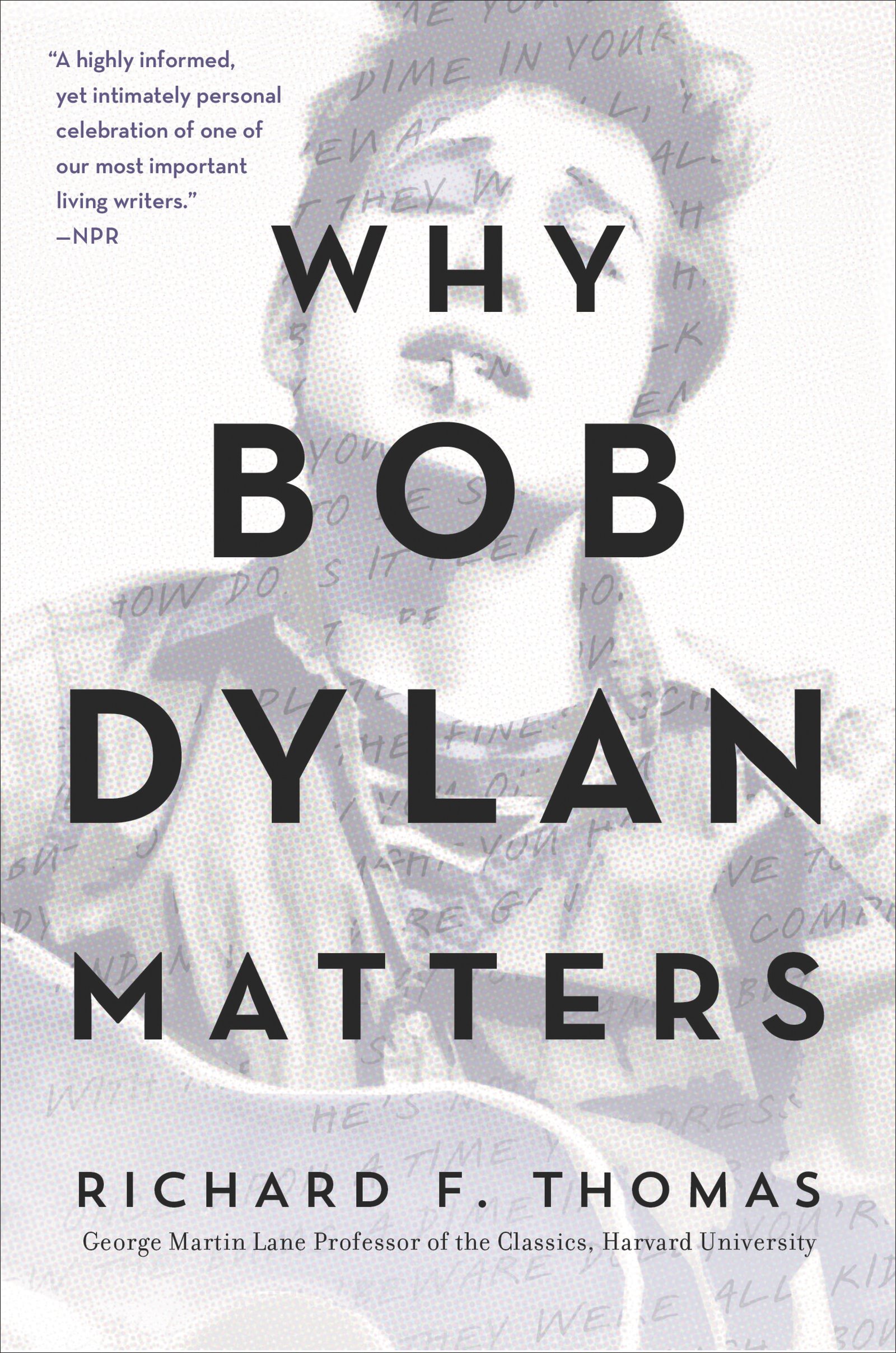 Come si inseriscono i suoi saggi all’interno della dylanologia, in particolare in relazione ad altri contributi fondamentali come quelli di Cristopher Ricks e Greil Marcus?
Come si inseriscono i suoi saggi all’interno della dylanologia, in particolare in relazione ad altri contributi fondamentali come quelli di Cristopher Ricks e Greil Marcus?
Sarei onorato nel vedere il mio nome vicino a questi. Il lavoro di Marcus, che indaga le tradizioni americane più profonde nella musica di Dylan, dalla fine degli Anni Sessanta nella sua Invisible Republic fino ai suoi scritti più recenti sul blues, nella musica e ben oltre, sono tra i contributi più importanti di sempre, non solo per comprendere Dylan. Cristopher Ricks, dalla sua, ha reso canoniche le ricerche su Dylan in ambito accademico. Il suo Visions of Sin espone i modi in cui Dylan faccia parte delle tradizioni letterarie degli ultimi due o tre secoli, in particolare quelle del 18º e 19º secolo. Il suo coinvolgimento con gli elementi olistici della poetica delle canzoni dylaniane nella sua analisi delle rime, della prosodia e del significato di “The Lonesome Death of Hattie Carroll” è magnifico. Il mio libro è in qualche modo diverso. Pongo l’accento su forme di intertestualità più volontarie, che implicano l’utilizzo verbatim degli autori, in particolare – ma non solo – dell’antichità classica, per capire in che modo le canzoni abitino e diventino parte di queste tradizioni, che Dylan porta nella terra dei vivi attraverso la sua arte.
Ero interessato ai metodi nuovi e complessi coi quali, specialmente nelle canzoni che ha scritto in questo secolo, il songwriting di Dylan affronta ciò che lui ha chiamato “transfiguration”. È qualcosa che ha sempre fatto con la tradizione folk, come ha chiarito per filo e per segno nella sua Nobel Lecture diffusa nel giugno 2017. In essa parlò di acquisire e assorbire il gergo, ma il modo in cui descrive quel processo è degno di nota: “You’ve heard the deep-pitched voice of John the Revelator and you saw the Titanic sink in a boggy creek. And you’re pals with the wild Irish rover and the wild colonial boy.” “Ascoltato, visto, essere compagno di”. Questa precoce trasfigurazione attraverso l’intertestualità conduce a un esito parallelo con gli autori classici, ma maggiore. Quando in “Workingman’s Blues #2” canta “No one could ever say that I took up arms against you”, Dylan diventa Ovidio in esilio, le cui precise parole Dylan offre al cantante. Quando in “Early Roman Kings” cita testualmente lo scherno che Ulisse scaglia trionfalmente nei confronti di Polifemo da una specifica traduzione dell’Odissea (“I’ll strip you of life, strip you of breath / Ship you down to the house of death”) il cantante diventa Odisseo. Ma quel cantante, nella stessa canzone, era anche “up on black mountain the day Detroit fell”, un cantante trasfigurato di 2500 anni, presente anche nei conflitti razziali del 20° secolo. Rintracciare il ruolo di questa intertestualità è stato uno degli scopi del mio libro. 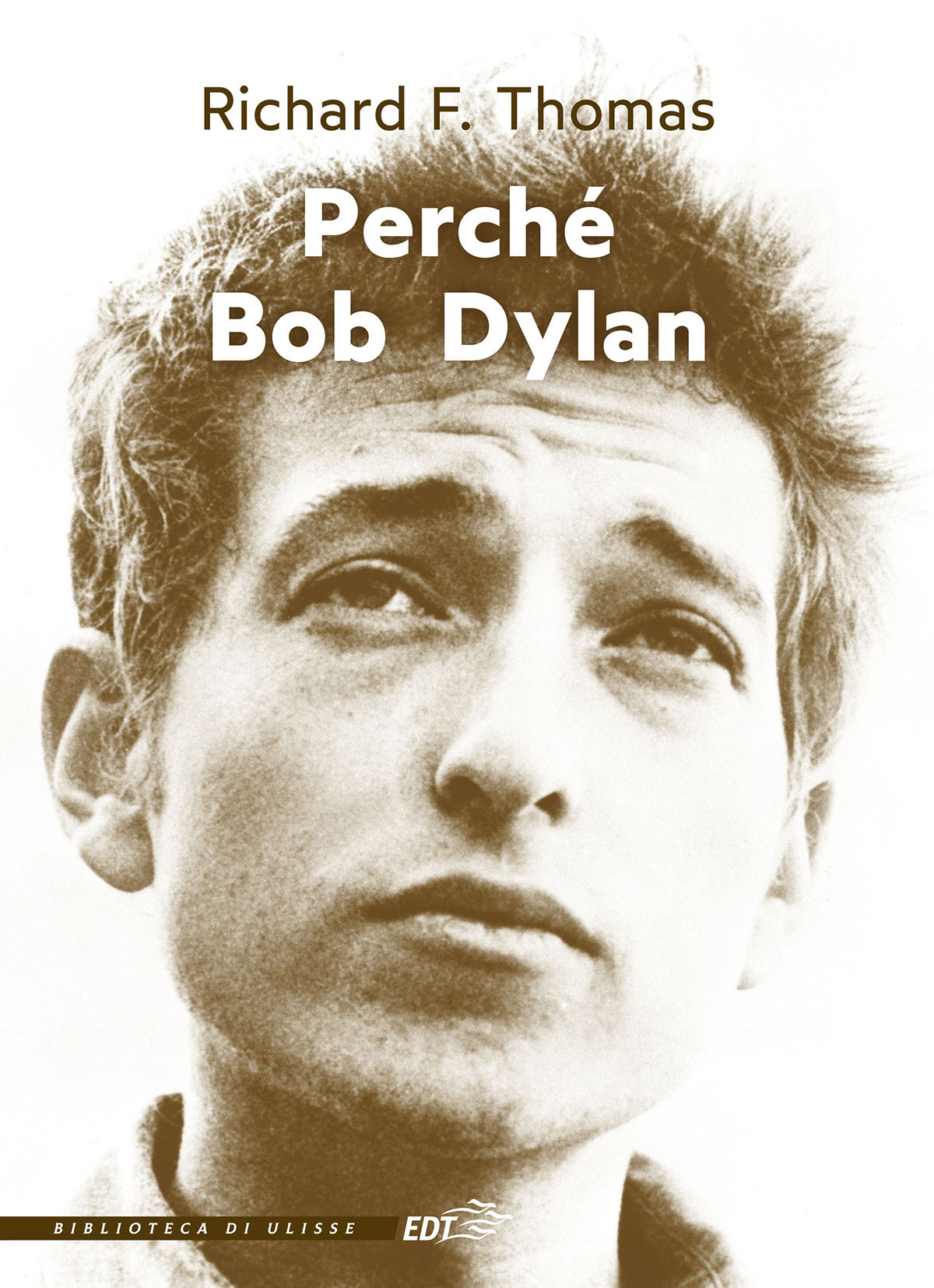
Studio Bob Dylan, i classici greci e latini e la letteratura italiana da molti anni. Ho sempre ritenuto straordinario quanto abile e originale sia Dylan nel connettere tra loro e armonizzare autori così disparati all’interno delle sue canzoni. Nessuno canta Dylan come Dylan, per citare una frase ormai proverbiale, ma io mi spingo oltre e affermo che nessuno scrive come lui. Come Dylan “gestisce” le sue fonti?
Sì, nessuno scrive come Dylan, e nessuno, nella sua stessa arte o in altri campi, nel vivere il processo creativo, legge e pensa come Dylan. Lo facevano Virgilio, Dante e Milton. Lo faceva Eliot. Dylan ha occhio per la poesia del linguaggio quando la incontra nelle sue eclettiche letture. Prendete la sesta strofa di “Ain’t Talkin’” nella versione pubblicata sull’album Modern Times, non presente nel libro ufficiale di testi dato alle stampe da Dylan: “All my loyal and my much-loved companions / They approve of me and share my code / I practice a faith that’s been long abandoned / Ain’t no altars on this long and lonesome road”. I primi tre versi, come molti di noi hanno notato, appartengono a tre differenti composizioni delle opere dell’esilio di Ovidio nella traduzione di Peter Green. Nella traduzione della Penguin, i versi in questione (Tristia 1.3.65, Epistuale ex Ponto 3.2.38, Tristia 5.7.63-4) si incontrano in un raggio di 150 pagine. E gli “altars on that long and lonesome road” appartengono al mondo del peregrinare del blues ma anche a quello di Ovidio, dove altari sul ciglio della strada si potevano incontrare dalla Via Appia fino al Mar Nero. Nessuno se non Dylan poteva prendere quel libro e dar vita a quella strofa, completamente coerente all’interno di un brano il cui titolo ruota intorno al ritornello di un brano bluegrass dei Stanley Brothers, “Highway of Regret”: “Ain’t talking, just walking / Down that highway of regret / Heart’s burning, still yearning / For the best girl this poor boy’s ever met”. E questo prima ancora che si inizino a rintracciare gli altri intertesti: Poe, Twain, Henry Timrod, la Genesi e i Vangeli del Nuovo Testamento. Peter Green crea versi poetici in risposta ai componimenti ovidiani: “a place ringed by countless foes”, “may the gods grant […] that I’m wrong in thinking you’ve forgotten me”; “every nook and corner had its tears”; “wife dearer to me than myself, you yourself can see” e così via. Dylan ha preso questi versi e ne ha riutilizzati pochi in ciascuna delle canzoni, rendendoli parte della sua stessa materia. In un caso, uno è diventato anche il titolo di una canzone presente su Together Through Life: “beyond here lies nothing”. Come per l’intertestualità nelle mani di altri grandi artisti, i versi che Dylan ruba con successo e rinnova portano con sé, una volta che ne riconosciamo la fonte, la loro ambientazione ovidiana: un poeta in esilio, sul posto o nella mente, che invecchia “in the last outback at the world’s end”.
Come in tutta la grande letteratura, Dylan è molto più avanti dei critici, o decisamente più indietro rispetto al suo tempo, che è poi la stessa cosa. All’inizio c’erano critici che negavano la presenza di Ovidio nella canzone e nell’album, in parte perché si erano imbattuti in vecchie traduzioni sul web, e così la trasfigurazione non funziona. Occorre partire dalla traduzione che Dylan ha usato, la Penguin, così come ha usato l’edizione Penguin dell’Odissea nella traduzione di Robert Fagles. E a molte persone non piace che le canzoni di Dylan siano composte col tessuto di altro materiale, per di più separato come in queste canzoni. Si tratta di un ritorno al Romanticismo, all’idea di Wordsworth per cui la poesia è uno “spontaneous overflow of emotion”, anche se ciò non è mai stato vero, neppure per lui. Non trovo alcuna stranezza nell’intertestualità e nella trasfigurazione perché è così che altri grandi poeti del passato hanno lavorato, nell’antichità passando per il Medio Evo e il Rinascimento fino al 18° secolo, nelle tradizioni letterarie del latino e delle diverse lingue.
L’incisivo “debellare superbos” di Virgilio, Eneide VI, compare in Bob Dylan in “Lonesome Day Blues” (“taming the proud”), tratta dal capolavoro “Love and Theft” (2001), e un affascinante riferimento alle guerre civili (siano esse romane o americane) compare in “Bye and Bye”, contenuta nello stesso album. Su Rough and Rowdy Ways, Dylan sembra particolarmente attratto dalla figura di Cesare, che è menzionato esplicitamente in “My Own Version of You” e la cui presenza aleggia in “Crossing the Rubicon”. Cosa cerca di comunicarci Dylan con questi indizi?
Giulio Cesare è noto a Bob Dylan almeno sin dal 15 marzo 1957, sia che Bob Dylan ricordi o meno quel giorno di marzo in cui lui, quindicenne, e il Latin Club di cui era membro a Hibbing pubblicarono un articolo che lo commemorava proprio alle Idi di Marzo. A quel tempo la sua mente era probabilmente più concentrata sulle prenotazioni che la sua band, The Golden Chords, otteneva allo snack bar Van Feldt. Si tratta, in ogni caso, di un fatto provato, come illustro nel libro, che lui e il dittatore romano erano già in buoni rapporti a quei tempi! Le opere di Shakespeare possono avere aiutato la sua conoscenza di Cesare dal momento che probabilmente Dylan aveva visto Marlon Brando interpretare Marco Antonio nella trasposizione filmica di quella tragedia, uscita nel 1953 per la regia di Joseph L. Manckiewicz. A dire il vero quel film, che ritornò nella programmazione dello State Theatre di Hibbing il 9 febbraio 1955, potrebbe essere uno dei motivi per cui si iscrisse al corso di latino l’autunno successivo. Chi lo sa.
Dylan, inoltre, è sempre stato interessato alle guerre civili, ed era stato uno storico della guerra civile americana ben prima del 2002, quando compose e incise “’Cross the Green Mountain” per il film Gods and Generals (2003). Circa nello stesso periodo, nella sua autobiografia Chronicles Volume 1, discute di quel conflitto americano così influente con parole che dimostrano quanto a lungo abbia abitato nella metà del 19° secolo con la mente, in un tempo in cui, con le sue parole, “America was put on the cross, died, and was resurrected”. E le conseguenze di questo abitarvici non devono essere sottostimate. Così continua Dylan: “The godawful truth of that would be the all-embracing template behind everything that I would write”. Dylan, in modo piuttosto perspicace, vede nei proprietari di piantagioni del sud uno specchio della “Roman republic where an elite group of characters rule supposedly for the good of all” (Chronicles 84–85). Anche qui torna di nuovo indietro fino a Roma, come ha fatto per tutta la vita.
Ai tempi di Chronicles aveva già fuso le guerre civili americane con quelle romane connettendo l’Eneide di Virgilio con The Adventures of Huckleberry Finn di Mark Twain in “Lonesome Day Blues” e, nello stesso album, attraverso allusioni in “Bye and Bye” (“I’ll establish my rule through civil war”) e forse in “Honest with Me” (“I’m here to create the new imperial empire”). Questo interesse emerge poi in “Ain’t Talkin’” (2006), dove la connessione con Roma è innegabile considerando quanto spazio viene riservato alla poesia ovidiana. In “I’ll avenge my father’s death then I’ll step back” Dylan incarna il figlio adottivo di Cesare, il primo imperatore romano Ottaviano Augusto, che nelle sue Res Gestae scrive: “Ho mandato in esilio con procedure legali quelli che uccisero mio padre” e “non ho accettato la dittatura […] che mi fu offerta dal popolo e dal senato”. È ritornato al tema delle guerre civili e a quello cesariano – e forse ai colli di Roma – in “Scarlet Town”, pubblicata nel 2012 (“In Scarlet Town you fight your father’s foes / Up on a hill a chilly wind blows”). Ho scritto di tutto questo nel libro. E poi, nel 2020, eccolo di nuovo lì, in “My Own Version of You”, una canzone che è interamente basata sull’intertestualità, nella quale si chiede “what would Julius Caesar do”. E, ovviamente, l’attraversamento del Rubicone, la firma di Cesare. Dylan è indubbiamente incuriosito dagli assassinii – si vedano i riferimenti al Presidente McKinley in “Key West” e a John Fitzgerald Kennedy in “Murder Most Foul”. Per questo non è affatto sorprendente che Dylan, che ha dichiarato che se dovesse rifare tutto daccapo vorrebbe essere un professore di storia romana, sia ritornato a Cesare. In “Crossing the Rubicon” di certo ciò non è semplicemente un tema: Dylan è diventato Cesare, trasfigurato mentre compie quel fatidico passo al termine di ogni strofa. In questo modo esaudisce la profezia che aveva pronunciato in un’intervista a Rolling Stone con Mikal Gilmore nel 2012: “Chi può dire chi sia stato trasfigurato e chi no? Chi può dirlo? Forse Aristotele? Forse lui è stato trasfigurato? Non saprei dirlo. Forse Giulio Cesare è stato trasfigurato”.
Recentemente un altro grande studioso di Dylan, Alessandro Carrera, Professore alla University of Houston, ha cercato di spiegare come mai Dylan citi spesso passi di Omero, e in particolare dell’Odissea, dal 2012 a oggi. Carrera sostiene che il metaforico esilio di Bob Dylan, evidenziato nell’album Modern Times (2006) attraverso i riferimenti frequenti ai Tristia e alle Epistulae ex Ponto di Ovidio, sia terminato, che ora il cantante stia affrontando il suo nostos (“I’m slow coming home”, canta in “Mother of Muses”) e che, nella recente (2014) riscrittura di “Workingman’s Blues #2”, faccia i conti con ciò che per lui rappresentano Iliade e Odissea. Che ne pensa?
Sì, certamente con l’Odissea, come ho scritto quando mi sono occupato delle modifiche al testo di “Workingman’s Blues #2”. Non so fino a che punto si sia avvicinato all’Iliade finora, benché nella Nobel Lecture si riallacci alla questione del codice eroico iliadico che emerge nell’Odissea, con l’ombra di Achille che nell’Ade si rende conto che la ricerca dell’onore e della gloria è vuota e che essere vivi è tutto quello che conta. Nella Nobel Lecture Dylan ci presenta Achille che parla a Odisseo: “It was all a mistake. ‘I just died, that’s all.’ There was no honor. No immortality”. Anche questo è un altro straordinario esempio di intertestualità.
E, senza dubbio c’è anche il tema del nostos, il ritorno a casa. Tutti lo viviamo, ma il concetto di casa è cambiato. Non più Itaca, non più Hibbing. Per questo Dylan include il country “Green Green Grass of Home” tra le canzoni che affrontano i temi presenti nell’Odissea. Il cantante immagina di essere ritornato a casa ma in realtà è in prigione, diretto verso la forca allo spuntare del sole accompagnato da un anziano prete addolorato. Tutti verranno a trovarlo quando sarà sotto un mucchio di terra, sotto la vecchia quercia accanto alla quale era solito suonare prima che la sua vita fosse distrutta, forse la stessa quercia che Dylan cita in “Duquesne Whistle”. Non puoi tornare a casa per davvero. Come molti poeti che portano avanti la tradizione di Omero, Dylan lo sa: per questo ritengo, cosa che ho scritto nel libro ben prima che fosse pubblicata “Mother of Muses”, che Dylan abbia letto, e stia “sfidando”, il grande poeta greco della moderna Alessandria, Kavafis. Per Kavafis il ritorno a Itaca è ciò che è fondamentale, vivere la vita stessa. La sua poesia “Ithaca” indica che l’isola è soltanto la destinazione: “non affrettare il viaggio; / fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio / tu metta piede sull’isola”. Questo è ciò che mi trasmette la conclusione di “Mother of Muses”: come per Kavafis, per Dylan e per tutti noi, non c’è motivo di accelerare il viaggio: “I’m travelin’ light and I’m slow coming home”.
Cosa ne pensa di Bob Dylan come storico? Il suo modo di rivivere, riscrivere e spesso modificare la storia è avvincente e meticoloso. Quale storiografo greco o latino le ricorda?
Di certo Bob Dylan non è uno storico nel senso moderno del termine: non ricerca assolutamente verità fattuali. Mostrano ciò le sue prime canzoni, che probabilmente erano lo specchio degli insegnamenti non troppo fantasiosi con cui era entrato in contatto: “memorizing politics of ancient history / flung down by corpse evangelists” e “the pain / of your useless and pointless knowledge”. Tuttavia, è interessante il fatto che da alcuni anni Dylan abbia iniziato a fare riferimento a storiografi e filosofi antichi, come Tucidide, Cicerone, Tacito, dal momento che condivide con loro la prospettiva di una storiografia di tipo maggiormente creativo. In inglese la parola “history” contiene “story”, mentre in italiano si utilizza una sola parola, “storia”. Ecco, la storiografia antica mirava non tanto al vero – spesso impossibile da catturare – quanto al verosimile, alla credibilità, che secondo Cicerone andava raggiunta costruendo le parti della storia come si costruisce un edificio. Anche Tucidide, che si attiene relativamente ai fatti, riporta verbatim discorsi che non ha sentito e discorsi che ha sentito. I discorsi che riporta ci fanno presumere che essi fossero davvero tali, considerati gli eventi che poi sarebbero seguiti alle parole. Visti i fatti, dovevano essere quelle le parole.
C’è poi un elemento di storytelling: mettere insieme cose che devono essere accadute. Succede lo stesso in Tacito, cui Dylan fa riferimento in più occasioni e che racconta così dell’uccisione di Agrippina da parte di Nerone, suo figlio: “poi, protendendosi verso il centurione che stringeva la spada per infliggerle il colpo letale, esclamò ‘colpisci l’utero!’, e venne uccisa con molte ferite”. Come poteva Tacito sapere cosa disse Agrippina? Il matricidio era avvenuto quando lui aveva circa tre anni. Tuttavia la frase è verosimile e funziona, e Tacito, come Dylan, avrebbe detto che si deve scrivere una storia che funzioni. Prendiamo la storica ballata “Hurricane”, riguardante il processo per omicidio intentato a Rubin “Hurricane” Carter. Probabilmente il poliziotto non ha mai detto “Wait a minute, boys, this one’s not dead”, ma potrebbe averlo fatto, è verosimile, e, cosa ancora più importante, funziona. Entrambe le frasi ti catapultano al centro della scena.
Insomma, lo scrivere canzoni ha alcuni aspetti in comune con il metodo dello storytelling che gli antichi utilizzavano per scrivere la storia. Le canzoni folk, in particolare le ballate, sono una forma di storia orale: “Robin Hood and the Butcher”, “The Earl of Errol” “Rob Roy”, “Dumbarton’s Drums”. Le versioni di Dylan sono aggiornamenti tesi a rendere storia eventi trovati magari nell’oscurità di un ritaglio di giornale o di un archivio, come accade in “The Lonesome Death of Hattie Carroll e “Joey”, che raccontano la morte di due persone realmente esistite. Non importa se William Zanziger avesse un “diamond ringer finger” o no, o se Joe avesse visto davvero i suoi assassini che entravano nella tavola calda “as he lifted up his fork”. Entrambe le cose sono plausibili e ci aiutano a dipingere un quadro, a “terminare l’edificio”, la exaedificatio, la metafora che usa Cicerone mostrare come si deve arricchire un discorso.
“Ut pictura poësis” (“La poesia è come un dipinto”), scrive Orazio nella sua Ars Poetica (Epistula ad Pisones). Nel 1974 Bob Dylan fu profondamente influenzato da Norman Raeben, pittore ebreo newyorchese che gli diede lezioni di pittura. Dylan è anche un discreto pittore. Pensa che la massima di Orazio possa collegarsi al suo modo di comporre canzoni?
Come sai, nello spiegare in quali aspetti la poesia, o in questo caso la scrittura di canzoni, è come la pittura, Orazio si spinge oltre: alcuni guardano in piedi da vicino, altri da lontano. Inoltre distingue la poesia/il dipinto che si può leggere/osservare una sola volta da quelli di cui non si è mai stanchi. Le canzoni di Dylan sono generalmente del secondo tipo. Puoi ritornarvi di continuo, non ti stancano mai, specialmente se si considera quanto variano gli arrangiamenti dei suoi brani di anno in anno, di sera in sera. La pittura e la scultura di Dylan sono estremamente affascinanti, ma avrei bisogno di approfondirle maggiormente. Ho avuto l’occasione di vedere la mostra Mondo Scripto, contenente suoi testi scritti a mano e disegni. Ho pensato davvero a Orazio mentre guardavo in piedi da vicino quelle opere. È particolarmente emozionante essere vicini alla rappresentazione della scena di una canzone con al fianco il testo scritto a mano dal suo autore. Stai leggendo, guardando e ascoltando in silenzio, nella tua testa, la canzone: si tratta di un’affascinante sinestesia, una produttiva fusione dei sensi. Per quanto riguarda Raeben, Dylan l’ha citato ed è chiaramente importante per la sua carriera di pittore. I critici hanno parlato a lungo del suo impatto su Blood on the Tracks, in particolare in brani visivamente potenti come “Shelter from the Storm” e “Simple Twist of Fate”. I Greci la chiamarono enargeia, chiarezza, l’abilità di dipingere un quadro con le parole, un talento che Dylan aveva già nel 1966, in “Visions of Johanna”. Chi gli aveva insegnato a scrivere in quel modo? Le muse, ovviamente, come ha finalmente rivelato nel suo ultimo album.
Nell’importante intervista di Roma del 2001, Dylan tratta di molti argomenti. Mi ha sempre colpito il momento in cui fa riferimento alle “età” dell’uomo in termini simili a quelli di Esiodo. A un tratto il dibattito sfuma e si cambia argomento. Sembra quasi che Dylan abbia evitato di concludere il discorso o che semplicemente non avesse voglia di spiegare la cosa. Di cosa pensa parlasse? Questo tema emerge nei suoi brani?
Come sai, nel libro mi occupo di quell’intervista, benché forse ci sarebbe altro da dire in merito. Dylan menziona tutte e cinque le età che compaiono nelle Opere e giorni di Esiodo: quella d’oro, quella d’argento, quella di bronzo, poi prosegue ritenendo ci sia “the Heroic Age someplace in there” e chiude dicendo che “we’re living in what some people call the Iron Age”. Il riferimento a Esiodo è preciso. È l’unica fonte antica che nomina un’età degli eroi insieme a quelle dei metalli, probabilmente in riferimento ai testi omerici e agli eroi che combatterono e morirono a Troia. Non so perché Dylan abbia tirato fuori l’argomento. I giornalisti non hanno colto la cosa, ed è forse per allontanarsi da quelle precise allusioni che Dylan conclude dicendo: “We could really be living in the Stone Ages”. A questo punto un giornalista, scherzando, parla di “Silicon Age” e l’occasione si è persa, la stella cadente è svanita, con Dylan che risponde “Exactly”, capendo di non essere stato compreso. Mi sono chiesto spesso cosa avrebbe risposto se gli fosse stato chiesto se le età esiodee erano entrate o meno nelle sue opere. Forse avrebbe evitato anche quella domanda dal momento che nella stessa intervista gli era già stato chiesto quali nuovi poeti leggesse e lui aveva risposto: “I don’t really study poetry”. Insomma, non lo sapremo mai. Ma penso si interessi delle età greco-romane sin dalla fine dei ‘70s. A Tulsa [dove si trova il Bob Dylan Archive, NdA] esistono bozze del testo di “Changing of the Guards” che sembrano evidenziare un’influenza dell’Ecloga IV di Virgilio per quanto riguarda l’attraversare a ritroso le età e ritornare da quella del ferro a quella dell’oro, a un passato utopico. Il riferimento a “Jupiter and Apollo”, conservato nella versione del brano poi incisa, viene proprio da lì.
Nel 2020 hai pubblicato un ottimo articolo, “’And I Crossed the Rubicon’: Another Classical Dylan” (in Dylan Review 2.1, Summer 2020), dove si occupa del “classical world of the ancient Greeks and Romans in the songs of Rough and Rowdy Ways”. Quale “tipo” di classicità vi ha trovato?
Dylan stesso ci dice che rapporto c’è tra l’album e gli antichi nell’ultima intervista che a oggi ha rilasciato, quella pubblicata sul New York Times nel giugno 2020, rilasciata a Douglas Brinkley qualche settimana prima. Fece lo stesso prima dell’uscita di “Love and Theft” alla conferenza romana del 2001, quando fece presagire la presenza di Virgilio nel disco: “when you walk around a town like this, you know that people were here before you and they were probably on a much higher, grander level than any of us are”. Non so perché Brinkley abbia chiesto a Dylan come mai “When I Paint My Masterpiece” fosse ritornata nelle scalette dei suoi concerti dal 2018 dopo anni di assenza. La risposta di Dylan è un segno rivelatore riguardo all’album che sarebbe uscito dopo una settimana: “I think this song has something to do with the classical world, something that’s out of reach. Someplace you’d like to be beyond your experience. Something that is so supreme and first rate that you could never come back down from the mountain. That you’ve achieved the unthinkable”. Come illustro nell’articolo, i classici greci e latini all’interno del nuovo album non sono tanto una trasfigurazione letterale del mondo antico quanto una loro nuova versione, più liberamente creativa, “my own version of you”. I cipressi dove le “Trojan women and children were sold into slavery” nella medesima canzone rimandano a Eneide II, ma, a differenza dell’uso che fa dell’Odissea e di Ovidio, non cita traduzioni conosciute ma crea la sua peculiare versione. La maggior parte del materiale appartiene ad altre canzoni del disco: “Crossing the Rubicon”, “Mother of Muses”, “Key West”. L’articolo fa parte di una rivista web gratuita, che accetta anche offerte, e chi vuole può recuperarlo lì. In quelle canzoni Dylan ha scalato le montagne del passato che aveva cantato in “Beyond Here Lies Nothin’”. Credo che parte di lui rimarrà su quelle montagne, come ho fatto io!
Nel medesimo articolo scrive che la “intertextuality, that has been a hallmark of Dylan’s song composition since the 1990s, continues on the new album”.
Sì, è proprio così. Ma è una versione più libera, più simile a quella di Viriglio o di Ovidio stessi, o di Dante, Milton ed Eliot. Non è citazione e giustapposizione, come accadeva con Virgilio accanto a Mark Twain e Junichi Saga in “Lonesome Day Blues” o con Ovidio ed Henry Timrod in “Ain’t Talkin’”. È, piuttosto, mettere alla prova alcune idee e dar vita a mondi ricostruiti all’interno di un suo nuovo mondo. Il cantante di “Crossing the Rubicon” potrebbe essere Giulio Cesare nel giorno in cui passò alla storia come lo scellerato generale che distrusse la repubblica, che “looked to the east and crossed the Rubicon”. È la direzione giusta, quella verso la quale Cesare deve aver attraversato il fiume che “goes gently as she flows” a nord verso l’Adriatico. Ma non troverai questo verso nella Vita di Cesare di Suetonio o nel De Bello Civili di Cesare. Insieme al mondo classico, la canzone ci dice che il “Rubicon is the (non “a”) Red River”. Ciò ci riporta indietro a “Red River Shore”, brano che Dylan incise nel 1997 (poi pubblicato nel Bootleg Series Vol. 8, 2008, NdA) e che a sua volta ci riporta al Red River del “suo” Minnesota e alla Red River Valley texana della canzone di Jules Verne Allen che Gene Autry canta nell’omonimo film. Questa è solo una minuscola parte dell’intertestualità di Rough and Rowdy Ways, antica e moderna.
Come abbiamo già detto, in Modern Times Dylan cita spesso le opere di Ovidio della relegatio (Tristia ed Epistulae ex Ponto). In “My Own Version of You”, su Rough and Rowdy Ways, canta delle “Trojan women and children” che “are sold into slavery”, e lei nota che qui il riferimento non è alle Troiane di Euripide ma piuttosto a Virgilio, Eneide II. Qual è il viaggio di Bob Dylan? È ancora “a stranger here in a strange land”, come cantava in “Red River Shore”?
Chi non lo è? Se il passato è un territorio sconosciuto, anche solo vivendo la nostra epoca rimarremo stranieri in una terra straniera, dove nulla è familiare. Ma la memoria creativa di Dylan ci permette di tornare indietro nel tempo con lui e chiarirlo, ricreando mondi che includono le nostre personali esperienze, mondi che contengono moltitudini. Il viaggio di Dylan è una vita, o una moltitudine di vite, in canzoni, ed è stato un piacere per innumerevoli migliaia di persone come noi aver navigato, e stare ancora navigando, con lui in questo viaggio. “I’ve already outlived my life by far”, sostiene il cantante di “Mother of Muses”. Ci riporta alla mente la Sibilla virgiliana alla quale Apollo concede una vita lunghissima ma non un’eterna giovinezza, e questo è ciò che la rende umana come noi. È un altro modo di essere stranieri in una terra straniera, dove spazio e tempo sono sostanzialmente intercambiabili. Questo è soltanto uno degli approcci che Dylan ha da sempre seguito nello scrivere e nel cantare le “nostre” canzoni per noi.
Grazie per il suo tempo, Professor Thomas.
(Samuele Conficoni)








