BEACH HOUSE, “Bloom” (Sub Pop, 2012)
 I Beach House sono uno di quei motivi per cui bisognerebbe smettere di fare i nostalgici. Tre album ineccepibili, canzoni che hanno segnato in un modo o nell’altro questi anni. E un sound davvero inconfondibile. Si potrebbe obiettare contestandone monotonia. Per via delle atmosfere vagamente monocorde che caratterizzano gli album del duo di Baltimora. Ma, provando a guardarsi indietro, quante grandi band del passato erano altrettanto uniformi in atmosfere, arrangiamenti e linee vocali? “Myth” è arrivata con settimane d’anticipo per presentare il secondo album dei quattro sotto la mitica Sub Pop a confermare tutto questo.
I Beach House sono uno di quei motivi per cui bisognerebbe smettere di fare i nostalgici. Tre album ineccepibili, canzoni che hanno segnato in un modo o nell’altro questi anni. E un sound davvero inconfondibile. Si potrebbe obiettare contestandone monotonia. Per via delle atmosfere vagamente monocorde che caratterizzano gli album del duo di Baltimora. Ma, provando a guardarsi indietro, quante grandi band del passato erano altrettanto uniformi in atmosfere, arrangiamenti e linee vocali? “Myth” è arrivata con settimane d’anticipo per presentare il secondo album dei quattro sotto la mitica Sub Pop a confermare tutto questo.
Autoprodotto con la collaborazione di un veterano come Chris Coady, la quarta fatica dei due è nata a Tornillo. Una delle tante terre di nessuno del Texas, nei Sonic Ranch Studios. Storico complesso a due passi dal Messico, noto per aver accolto molti grandi del motown fino ad arrivare a eroi regionali quali gli At The Drive In. Non che i Beach House, dopo “Devotion” avessero bisogno di assorbire atmosfere ulteriormente desertiche e solitarie.
La voce elegante e retrò dell’ormai trentenne Victoria Legrand si protende su linee e armonie ricorrenti, ma il songwriting è intatto. Pulito, essenziale, efficace. Oltre vent’anni dopo, i Beach House provano a riscrivere con sonorità più calde e americane la breve e controversa parabola del dream-pop. E con risultati anche migliori. Merito di un’essenzialità mai abbandonata, appunto. Tastiere e arricchimenti sintetici non vanno mai oltre. E gli avvolgenti arpeggi del socio di Alex Scally trascinano l’ascolto in terre lontane e mondi altri senza eccessi.
Descrivere o semplicemente dare un’idea dei passaggi di “Bloom”, sempre sospesi tra sogno e (ir)realtà è un’impresa ardua e inutile. “Lazuri” e “Other People” seguono in tutto e per tutto le parabole di “Devotion” e “Teen Dream”. Drum-machine a bassa fedeltà, chitarre soffuse e ritornelli in cui Victoria lascia fatalmente senza fiato. I climax infrangono le barriere dei cuori più gelidi, dalle venature voodoo di “Troublemaker”. In “On The Sea” si rispolvera un po’ di soul e la sfida a un’altra singer dal bicchiere facile, Cat Power, è aperta.
Dream pop, si diceva. Si pensa subito, ascoltando una “Wild”, ai Cocteau Twins come derivazione più o meno immediata. Si può però affermare senza vergogna che non solo la vena melodica, ma anche le soluzioni compositive di Scally tra chitarre e synth, hanno poco e nulla da invidiare. Anche in “New Year”, brano apparentemente più debole e freddo che dopo qualche ascolto si scolpisce nel cuore quanto la canzone appena citata. In “Wishes” si materializza il compromesso emblematico tra le due scuole, quella più cantautorale a stella e strisce e quella Eighties.
Accompagnamento sempre polveroso e distante, toni da classica filastrocca noir riletta in chiave lynch-iana e chitarre tra Cure e shoegaze. “The Hours”, così, suona come una versione liturgica (o slowcore?!?) di “Soon” dei My Bloody Valentine. In fondo quello dei Beach House, più che una proposta musicale, suona sempre e comunque come una liturgia, un’esperienza spirituale piuttosto che un rito pagano. Magnetico, spettrale. Difficile da identificare in termini più o meno razionali.
I commoventi, sette minuti conclusivi della splendida “Irene” lo dimostrano fino alle ultime battute dell’album.
Senza respiro, con tanti flash agrodolci nella testa.
Tutto il resto conta relativamente poco.
88/100
(Piero Merola)
23 Aprile 2012

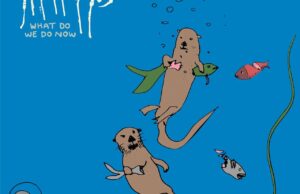







1 Comment