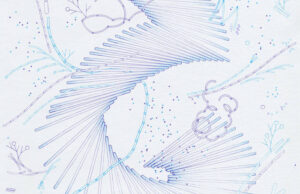THE PRETTY THINGS, S.F. Sorrow (Repertoire, 1968)
 “S.F. Sorrow is Born”: inizia con un’affermazione inequivocabile l’album che segnerà l’ingresso dei Pretty Things di Phil May e compagnia. La strumentazione usata, la circolarità acida dei suoni, i riflessi policromi della loro musica sono segnali altrettanto inequivocabili del salotto culturale che la band era solita frequentare: “Bracelets of Fingers” si apre con i “Love, Love…” che riportano alla mente gli Who di “Sell Out” e prosegue con un cantato che non è certamente immune da riferimenti al dinoccolato incedere vocale – trasognato e ironico – che faceva spopolare la voce di John Lennon su tutte le radio del regno unito.
“S.F. Sorrow is Born”: inizia con un’affermazione inequivocabile l’album che segnerà l’ingresso dei Pretty Things di Phil May e compagnia. La strumentazione usata, la circolarità acida dei suoni, i riflessi policromi della loro musica sono segnali altrettanto inequivocabili del salotto culturale che la band era solita frequentare: “Bracelets of Fingers” si apre con i “Love, Love…” che riportano alla mente gli Who di “Sell Out” e prosegue con un cantato che non è certamente immune da riferimenti al dinoccolato incedere vocale – trasognato e ironico – che faceva spopolare la voce di John Lennon su tutte le radio del regno unito.
Eppure, nonostante gli inequivocabili riferimenti musicali, il progetto portato avanti dai Pretty Things ha al suo interno qualcosa di molto più complesso, di molto più articolato, di molto più arduo. Può sembrare cosa da poco detta ai primi vagiti del 2004 ma ci troviamo di fronte alla prima “opera rock” della storia: passo dopo passo seguiamo la vita di Sebastian F. Sorrow, dalla sua nascita fino alla desolazione di una vecchiaia passata solo con le sue memorie, dopo aver attraversato guerre, lutti, perdite di coscienza nella droga.
Prima di “Tommy” o di “The Wall” i Pretty Things tracciano un universo malato, violento, nelle cui vene marce crescono i primi sintomi di pazzia, una pazzia senza consolazione, senza via d’uscita. Laddove gli Who e i Pink Floyd concludono le loro partiture con una luce di speranza, animati da un furore che cerca di abbattere fisicamente gli ostacoli che trova davanti, “S.F. Sorrow” si abbandona alla malinconia folk di “Loneliest Person”; non c’è più spazio per la rabbia, non ha più alcun senso combattere.
E in mezzo? E in mezzo l’ascoltatore viene bombardato da un caleidoscopio di idee, di immagini e di visioni che non hanno eguali nella musica dell’epoca: “She Says Good Morning” è una sfrenata marcetta dilaniata da sfrigolii sonori, realmente capace di mettere di buon umore, parente stretta delle atmosfere a metà tra il cinico e il sognante tanto care ai Kinks.
Straordinaria la lucida critica alla guerra di “Private Sorrow”, che ha in sé l’alchimia stralunata di un Barrett e la disanima sociale di cui si era fatto portavoce Davies, fino a terminare in improbabili fanfare zittite dal ritmo secco del tamburo, destinato a trasformarsi nell’ossessionante incedere di “Balloon Burning”, ovvero l’America secondo i Pretty Things, con tanto di deflagrazione centrale in un assolo sfrenato, che simboleggia tanto la caduta del pallone aerostatico nel quale perde la vita la fidanzata del buon Sorrow tanto la caduta del sempiterno “american dream”, destinato a dissolversi nei fumi psichedelici – e psicotropi – nei quali si rifugia la mente del protagonista, i cui prodromi sono presenti già nell’angosciante e frastornato lamento funebre di “Death”, nel quale esplodono dilatazioni sonore improvvise quanto attanaglianti.
Il “Baron Saturday” che compare nel brano successivo è un semplice pusher, tratteggiato come un incrocio tra il vaudeville brechtiano di Kurt Weill e il suono pastoso e tirato della black music – e la digressione percussiva centrale è a dir poco travolgente -, con tanto di straniata ipotesi pastorale. “The Journey” e “I See You” sono la caduta definitiva nell’acidità lisergica del trip allucinogeno, con Sorrow oramai sballottato completamente dagli eventi – e la voce instabile e drogata di May descrive la condizione psicofisica del personaggio con una partecipazione commovente -, mentre “Well of Destiny” è il risveglio dal sonno, con la consapevolezza di ritrovarsi nuovamente nell’incubo.
Gli ottundenti riverberi, le insopportabili acidità della chitarra, il loop organistico non concedono nulla alla gioia, prima di svanire improvvisamente. “Trust” sembra tornare alle atmosfere iniziali dell’album, ma non c’è più spazio ormai per la vitalità sprigionata da “She Says Good Morning”, rimane solo una memoria del passato, non tangibile, impossibile da far rivivere. Alla fine dei sogni, l’uomo rimane malinconicamente solo, ma quantomeno consapevole e non più in balia degli eventi. In “Old Man Going” i Pretty Things si lanciano nella descrizione della vecchiaia più pirotecnica che sia mai stata pensata, ma è un fuoco di paglia destinato ad estinguersi nell’acustica dolente di “Loneliest Person”. Il brano che va a chiudere un album perfetto, assolutamente impedibile, al di là (forse) delle stesse capacità dei suoi creatori, mai più in grado di mantenersi a questi livelli.